Conosci Turano Lodigiano
Pubblicato il 7 luglio 2007 e aggiornato periodicamente in base alle notizie che si riesce a reperire man mano
Veduta Panoramica di Turano Lodigiano
- Il percorso storico dell’area in cui si trova Turano Lodigiano
- Cartografia storica di Turano e di Melegnanello
- Edifici storici
- Edicole dei Santi
- Piste Ciclabili e Pedonali
- Aree Agro-Faunistiche
- Il Lago Gerundo e il Drago Tarànto o Tarantasio
Prefazione
Trovarsi a vivere a Turano Lodigiano dopo oltre 50 anni di vita passati in una città convulsa come Milano, non è certo un bell'impatto, non ci sono cinema ne teatri, non ci sono piscine, non ci sono locali di divertimento, ci sono solo tre bar, di cui uno nella frazione di Melegnanello e un'altro all'oratorio che però è legato agli orari d'apertura dello stesso, un ufficio postale, uno sportello bancario aperto solo qualche giorno alla settimana, i negozi si contano sulle dita di una mano e sono sempre più insidiati dalla presenza dei supermercati, che anche se sono a circa dieci chilometri di distanza fanno sentire la loro influenza sui loro incassi. Cosa può fare una persona, dopo una vita dedicata al lavoro e ancora abbastanza in salute? Chiudersi in casa di fronte al televisore con i suoi programmi ? No assolutamente, ti fanno il lavaggio del cervello!!! Andare al bar e sedersi li tutto il giorno con davanti una bottiglia di vino? Tanto meno ci si rincitrullisce!!!! Allora non resta che armarsi di una bella bicicletta e cominciare ad esplorare il territorio che ci circonda, o ancora meglio, scegliere un bel paio di scarpe adatte e andare finchè non si è veramente stanchi, io ho fatto questa ultima scelta dopo un paio di cadute dalla bici nei percorsi fuori strada. Così ho cominciato a scoprire le bellezze di questo territorio, il suo verde,
(guarda questo video per ammirare lo stupendo potere della natura), clicca qui>video.repubblica.it/natura/lo-sbocciare-delle-piantine-il-timelapse-e-ipnotico/134148/132689  i suoi campi,
i suoi campi, i suoi canali,
i suoi canali,
i suoi fiumi, 


anche quando non scherzano
il suo cielo,



le sue albe, i suoi tramonti,
i suoi tramonti,

la sua storia, le sue leggende.
le sue leggende. 
Domandando, curiosando, leggendo, consultando, ho trovato notizie, immagini e luoghi che anche coloro che sono nativi di questi luoghi spesso non conoscono. Queste mie informazioni/impressioni le ho raccolte qui di seguito ad uso di coloro che possono esserne interessati.
Riferimenti:
La stesura di questa serie di informazioni, ha lo scopo di cercare di riunire in un unico spazio (anche se solo in modo sintetico) dati che si trovano sparsi in diversi luoghi e su diversi documenti, pertanto non costituiscono un percorso di assoluta certezza.
-
parte è frutto di ricerca personale
-
parte è tratta da www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede
-
parte sono spunti dal libro di Don Aldo Zaini "Turanum storia di Turano Lodigiano"
-
parte sono spunti dal libro di GIACOMO MASSIMO BASSI "Turano Lodigiano e la sua gente nel 1900"
-
parte é tratta dal PGT di Turano Lodigiano
-
parte è tratta da un articolo del Comitato Vivere l'Acqua pubblicato a cura di Carlo Pisati su "Ritmi del maggio 2013" notiziario dell'Amministrazione Comunale di Turano Lodigiano
-
i dati sul lago Gerundo sono tratti da Wikipedia.it
Ci sono varie tracce di quale potrebbe essere il nome originario di Turano, si trovano infatti indicazioni quali: Tuiranum, Taurianum, o Turranum, tutti, o derivanti da toponimi di origine celtica o di origine romana Turris amnis -Torre del fiume, o addirittura di origine greca Turannos - potente signorotto che dominava con pugno di ferro la zona. Nulla lo conferma, solo seguendo un percorso storico, che va dalla conquista da parte di Roma, di quella fascia di territorio, che oggi chiamiamo pianura padana che negli anni intorno al 220-130 a.C.(avanti Cristo) diviene terreno di aspri scontri, già nel 218 a.C. quando le legioni Romane cercano di arrestare l’avanzata di Annibale Barca generale Cartaginese, che aveva attraversato la Spagna, la Francia e le Alpi con le sue truppe e decine di elefanti, travolgendo nella loro avanzata tutte le legioni che gli si oppongono, i Romani tentano di poter godere di un vantaggio cercando di usare il fiume Ticino come baluardo, ma ancora una volta l’avanzata delle truppe di Annibale è inarrestabile, i Romani vengono ancora sconfitti, ma organizzano una nuova linea di difesa sul fiume Trebbia dove però subiscono una nuova disfatta, devono passare ben 17 anni, nei quali Annibale scorazza per i territori Romani, nel 202 a.C., i Romani riescono a sconfiggere Cartagine e successivamente nel 146 a.C. a raderla totalmente al suolo. Eliminato questo nemico Roma riesce a portare un lungo periodo di tranquillità ed
espansione dei suoi territori. Nel 69 d.C.(dopo Cristo) si ha il primo accenno al nome di Turano, secondo i testi a cura di Lodovico Chiesa, ( Vita di S. Siro libro 2 cap. I°), che descrive il passaggio di S. Siro proveniente da Aquilea quando sostò a Turano e in località Melegnanello per proseguire successivamente per Pavia , poi ottocento anni nei quali non si sa più nulla di Turano.
Nel 69 d.C.(dopo Cristo) si ha il primo accenno al nome di Turano, secondo i testi a cura di Lodovico Chiesa, ( Vita di S. Siro libro 2 cap. I°), che descrive il passaggio di S. Siro proveniente da Aquilea quando sostò a Turano e in località Melegnanello per proseguire successivamente per Pavia , poi ottocento anni nei quali non si sa più nulla di Turano.
Segue una fase di decadimento della potenza di Roma ed iniziano le invasioni dei popoli barbari, primi i Visigoti negli anni dal 397 d.C. al 401 d.C.(dopo Cristo) poi gli Unni nel 452 d.C. infine gli Ostrogoti nel 489 d.C. le legioni Romane si erano dissolte assieme allo splendore di Roma, solo con l’intervento delle forze dell’Impero Romano d’Oriente, che ha come capitale Bisanzio la città fondata da Costantino, si riesce a sconfiggerli e scacciarli nel 535 d.C. e fino al 568 d.C. quella che oggi chiamiamo Italia rimane sotto il dominio dell’Impero di Bisanzio, quando i Longobardi dopo una serie di scontri con immense devastazioni e massacri ne assumono il controllo, il territorio e le popolazioni escono da questo periodo con un impoverimento generale , il continuo transito di eserciti contrapposti sottopone la popolazione a svariati spostamenti con la perdita dei raccolti, perché bruciati assieme ai villaggi o addirittura la mancata semina dei terreni, tanto che verso il 540 d.C. una tremenda epidemia colpisce tutto il territorio, in questa situazione di caos, miseria, incertezza, emerge il potere della chiesa cattolica che è l’unica forza in grado di dare la protezione che i più deboli cercano, riesce ad organizzare la distribuzione di viveri, elemosine e fronteggia anche il potere degli eserciti, già verso il 600 d.C. possiede ricchezze e terreni, in questo modo, attraverso gli ordini monastici di cui Benedetto da Norcia è il precursore, con la sua Regola, dà l’indicazione ai monaci di non limitarsi a pregare, ma di prestare attenzione ai poveri e agli sbandati, di coltivare la terra, di costruire gli strumenti da lavoro, di studiare e conservare le grandi opere del passato, si costruiscono quei complessi di rifugio e preghiera che sono i monasteri, nei quali insegnano ai rifugiati l’arte della coltivazione, della tessitura, dei lavori artigiani, si può dire che, dal loro insegnamento si sono poste le basi dell’industria del Medioevo.
E’ solo con il sorgere della potenza dei Franchi che si comincia ad invertire lo stato di arretratezza ed imbarbarimento in cui è piombata tutta l’Europa, i Franchi riescono a sconfiggere gli Arabi, che avevano già conquistato la Spagna e una parte della Francia, a Poitiers nel 732 d.C. poi nel 754 d.C. sconfiggono anche i Longobardi che controllavano l’Italia,. presentandosi così come i difensori della chiesa cattolica e di conseguenza di Dio, di cui il Papa è il suo rappresentante terreno, creano il Sacro Romano Impero, del quale viene incoronato imperatore nel 799 d.C. da Papa Leone III, il figlio di Pipino il Breve, Carlo I detto Magno, che riesce a mantenere unito l’impero fino alla sua morte nel 814 d.C. poi passa al suo erede Ludovico il Pio fino alla sua morte nel 840 d.C., ne segue un periodo di lotte tra gli eredi, che si conclude con la deposizione dell’ultimo dei suoi eredi e re dei carolingi Carlo il Grosso nel 887 d.C. Attraverso alterne vicende l’Italia nel 888 d.C. è governata da Berengario I il quale viene poi sconfitto e spodestato da Rodolfo di Borgogna nel 923 d.C. E' nel 924 d.C. che il nome di Turano, riemerge dal buio in cui era scomparso, a seguito della calata degli Ungari che riducono in rovina il Castello di Turano e nell'atto di vendita delle sue ruine si fa menzione anche del palazzo di Vairano da vendersi anch'esso perchè ormai indifendibile. Nel 927 d.C. il nome di Turano viene citato nuovamente in un documento in relazione all’esenzione del pagamento delle decime concessa dal vescovo di Lodi al monastero di San Pietro di Lodivecchio, nel corso del Medioevo la località ricorre nella documentazione soprattutto per i diritti esercitati su di essa dall’episcopato lodigiano. Nel 1218 il vescovo Ottobello fece costruire un ospedale a Turano che era un luogo di frequenti passaggi di pellegrini e viandanti, tanto che Alberto Vignati per la sua misericordia ne costrui un altro analogo come da legato del 1229. Nel 1437 i piccoli ospedali vengono chiusi a favore di quello più grande di Lodi. Il convento di San Lorenzo dell’Ordine dei Servi di Maria viene istituito nel 1485 dal conte Lorenzo Mozzanica; i frati ne prendono possesso solo il 15 maggio 1502 (Agnelli 1917; Sebastiani 1989) In età spagnola intorno al 1550 , quando il Contado lodigiano fu suddiviso nei Vescovati Superiore, di Mezzo, Inferiore di Strada Cremonese e Inferiore di Strada Piacentina, Turano apparteneva al Vescovato Inferiore di Strada Cremonese (tassa dei cavalli); parte del feudo dei Mozzanica, secondo la relazione di Gian Francesco Medici al visitatore de Haro nel 1609 contava 150 fuochi (Vigo 1983); il Convento di San Lorenzo nel 1619 conta tre frati, quattro frati nel 1690, sei frati nel 1750 ( Descriptio 1619 p. 128 Descriptio 1690 p. 265;Zambarbieri 1983 p 88). Nel 1629 il territorio di Melegnanello fu oggetto alle sopraffazioni e violenze delle soldataglie dei lanzichenecchi che erano dirette all'assedio di Mantova.
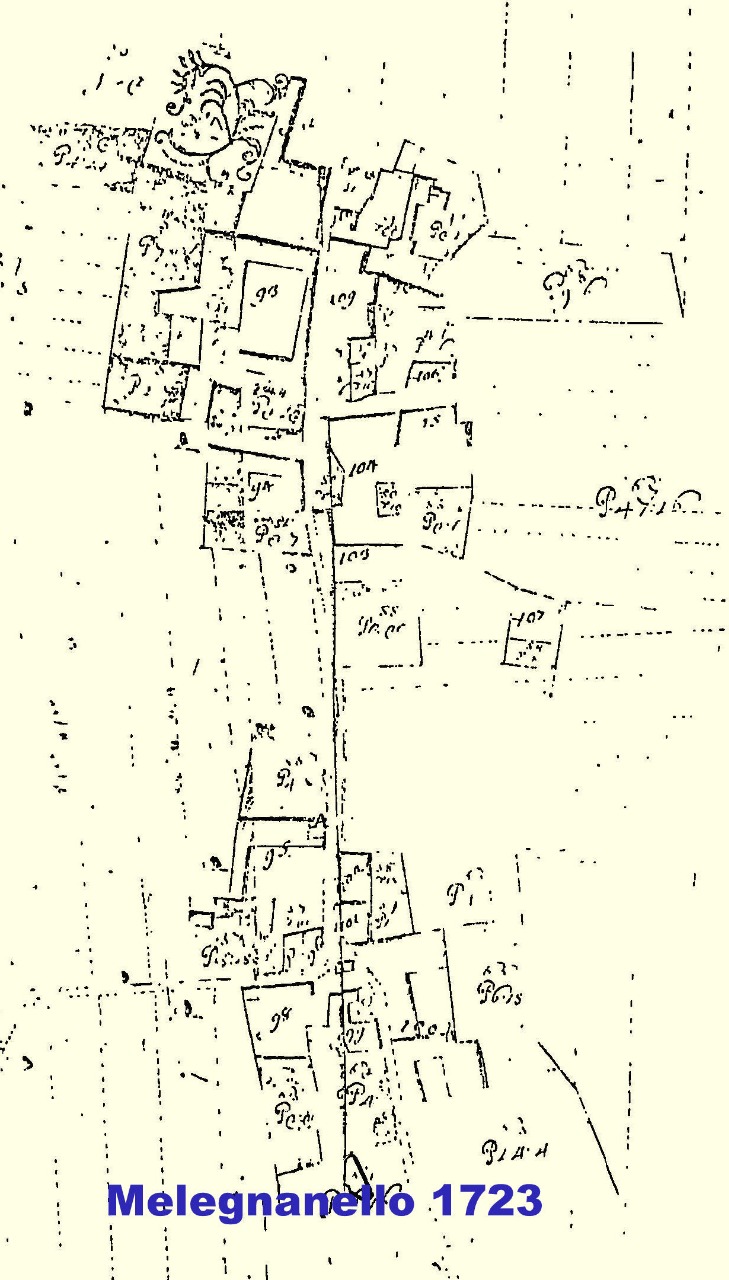

Durante il dominio Austriaco, il Comparto territoriale del 1751 il comune figura con Casa Calderari, Casa del Molinaro, Casa del Torchio, Casa dell’Osteria, Casa della Cura, Regonella, Cassina della Braila, Mirabello e Torre, Cassina Nova, Cassina dei Padri di S.Lorenzo e Mairaga ( Compartimento Ducato di Milano 1751) nello stesso torno di anni, l’inchiesta disposta dalla Regia Giunta per il Censimento accertò che Turano contava 618 abitanti ed era feudo dei Calderai, che l’avevano acquistato dai Cadamosto(Agnelli 1917) Rappresentante del feudatario era il podestà -abitante a Milano- che riceveva dalla comunità trenta lire annue d’onorario e che era rappresentato in loco da un luogotenente, esentato dal carico annuale, il console di Turano quindi prestava annuale giuramento sia all’attuario feudale, sia al podestà di Lodi. Privo di organi consiliari, il comune era amministrato da due deputati, uno eletto per il reale, l’altro per il personale, estratti a sorte annualmente tra i maggiori estimi. Completava l’organico amministrativo un cancelliere, stipendiato con quaranta lire all’anno e responsabile delle scritture, che consistevano negli ordini e nei registri dei “riparti antichi” consegnati agli esattori allo scadere del loro mandato. La riscossione delle taglie era affidata a un esattore, nominato con asta pubblica e con mandato biennale (risposte ai 45 quesiti, cart. 3048). Nel 1753 il comune era ancora compreso nel vescovato Inferiore di Strada Cremonese ( Indice pievi Stato di Milano, 1753) Nella seconda metà del 1700 la suddivisione in Città e Contado venne meno in seguito all’applicazione della riforma Teresiana; i vescovati vennero suddivisi in 24 Delegazioni, ognuna delle quali composta da un numero variabile di comunità: in seguito a tale riassetto, dunque Turano risulta compreso nella XVI delegazione ( editto 10 giugno 1757). Alla riorganizzazione del territorio non se ne affiancò una istituzionale; in linea di massima (con poche eccezioni), l’organizzazione politico-istituzionale delle singole comunità restò invariata. Quindi mantennero le tradizionali (naturalmente dove presenti) i convocati generali degli estimati, i deputati e i sindaci. Il convento di S. Lorenzo dell’Ordine dei Servi di Maria viene soppresso il 5 febbraio 1772 con dispaccio del 5 settembre 1771 (Camagni, Timolati 1885, p. 128; Elenco clero Stato di Milano) La riforma stabilita nel 1757 restò in vigore sino al 1786, anno durante il quale il governo austriaco decretò una nuova riorganizzazione dello Stato che prevedeva la suddivisione del territorio in otto province ( Milano, Mantova, Pavia, Cremona, Lodi, Como, Bozzolo e Gallarate) in forza dell’editto del 26 settembre 1786, il comune di Turano faceva parte della provincia di Lodi e in particolare della XVI Delegazione, Vescovato Inferiore (editto 26 settembre 1786 c).
Il territorio passa sotto il controllo dei Francesi che ne decidono una nuova suddivisione, secondo la legge del 1 maggio 1798 di organizzazione del Dipartimento dell’Adda, il comune di Turano faceva parte del distretto Castiglione (legge 12 fiorile anno VI a). L’assetto politico-amministrativo stabilito con tale legge, però viene superato poco dopo. Il 26 settembre 1798 venne emanata la legge di organizzazione di diversi dipartimenti della Repubblica, tra i quali quelli relativi ai comuni del Lodigiano: il dipartimento dell’Alto Po e quello dell’Olona (legge 5 vendemmiale anno VII) Turano venne incluso nel distretto IV del dipartimento dell’Alto Po.
Dopo i rovesci del 1799 e l’effimera restaurazione austriaca, il 13 maggio 1801 venne ripristinato il dipartimento dell’Alto Po (legge 23 fiorile anno IX) suddiviso in soli quattro distretti ( Cremona, Lodi, Crema e Casalmaggiore). Il comune divenne parte del III distretto con capoluogo Lodi, Cantone V di Casalpusterlengo. Era inoltre un comune di III classe e contava 635 abitanti. Nel 1809 venne introdotta una nuova organizzazione territoriale che prevedeva l’aggregazione di più comuni in un unico comune denominativo. Turano risulta così aggregato a Melegnanello (decreto 4 novembre 1809 c)
Ancora una volta il territorio passa nelle mani degli austriaci, con l’attivazione dei comuni in base alla compartimentazione territoriale del regno Lombardo-Veneto il comune di Turano inserito nella provincia di Lodi e Crema, apparteneva al distretto V di Casalpusterlengo (notificazione 12 febbraio 1816) La compartimentazione del 1844 lasciò in buona parte inalterata l’organizzazione della provincia in nove distretti. Nel 1844 Turano apparteneva al distretto di Casalpusterlengo ( notificazione 1 luglio 1844) in seguito alla notificazione del 23 giugno 1853 i distretti della provincia di Lodi e Crema pur composti dallo stesso numero di comuni, passarono da nove a sette. Turano era sempre parte del distretto di Casalpusterlengo ( notificazione 23 giugno 1853).
Turano e Melegnanello 1850
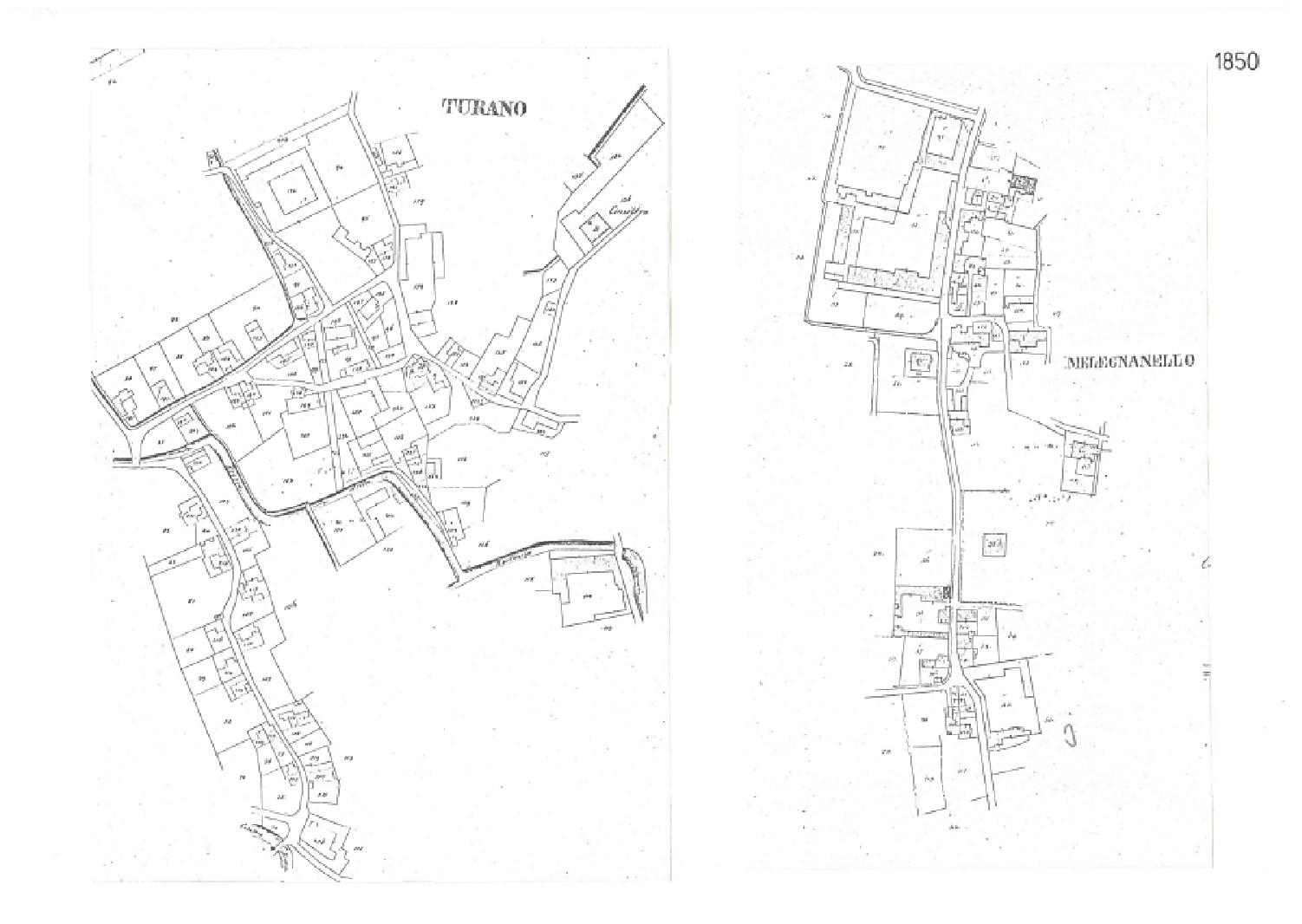
In seguito all’unione temporanea delle province lombarde al regno di Sardegna, in base al compartimento territoriale stabilito con la legge 23 ottobre 1859, il comune di Turano con 866 abitanti, retto da un consiglio di quindici membri e una giunta di due membri, fu incluso nel mandamento VI di Casalpusterlengo, circondario III di Lodi, provincia di Milano. Alla costituzione nel 1861 del Regno d’Italia, il comune aveva una popolazione residente di 878 abitanti (censimento 1861) In base alla legge sull’ordinamento comunale del 1865 il comune veniva amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio. Nel 1867 il comune risultava incluso nello stesso mandamento, circondario e provincia (Circoscrizione amministrativa 1867) Nel 1869 al comune di Turano vengono aggregati i soppressi comuni di Melegnanello e Robecco Lodigiano ( R.D. 29 gennaio 1869 n. 4869)
 popolazione residente nel comune : abitanti 2221 ( censimento 1871), abitanti 2283 ( Censimento 1881), abitanti 2275 (Censimento 1901), abitanti 2458 (Censimento 1911), abitanti 2362 (Censimento 1921). Nel 1924 il comune risultava incluso nel circondario di Lodi della provincia di Milano. In seguito alla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1926 il comune veniva amministrato da un podestà. Sino al 1928 il comune mantenne la denominazione di Turano e successivamente a tale data il comune assunse la denominazione di Turano Lodigiano (R.D. 20 dicembre 1928 n. 3175) popolazione residente: abitanti 2300 ( Censimento 1931), abitanti 2178 ( Censimento 1936). Nel 1937 al comune di Turano Lodigiano vennero aggregate, una zona di territorio staccata dal comune di Credera di Rubbiano, in provincia di Cremona e una zona di terreno disabitata, staccata dal comune di Moscazzano, in provincia di Cremona; sempre nel 1937 dal comune di Turano Lodigiano vennero staccate, una zona di territorio disabitata, aggregata al comune di Moscazzano e una zona di territorio aggregata al comune di Credera di Rubbiano. In seguito alla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1946 il comune di Turano Lodigiano veniva amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio, popolazione residente: abitanti 2281 (Censimento 1951), abitanti 1817 ( Censimento 1961), abitanti 1416 (Censimento 1971) nel 1971 il comune di Turano Lodigiano aveva una superficie di ettari 16.
popolazione residente nel comune : abitanti 2221 ( censimento 1871), abitanti 2283 ( Censimento 1881), abitanti 2275 (Censimento 1901), abitanti 2458 (Censimento 1911), abitanti 2362 (Censimento 1921). Nel 1924 il comune risultava incluso nel circondario di Lodi della provincia di Milano. In seguito alla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1926 il comune veniva amministrato da un podestà. Sino al 1928 il comune mantenne la denominazione di Turano e successivamente a tale data il comune assunse la denominazione di Turano Lodigiano (R.D. 20 dicembre 1928 n. 3175) popolazione residente: abitanti 2300 ( Censimento 1931), abitanti 2178 ( Censimento 1936). Nel 1937 al comune di Turano Lodigiano vennero aggregate, una zona di territorio staccata dal comune di Credera di Rubbiano, in provincia di Cremona e una zona di terreno disabitata, staccata dal comune di Moscazzano, in provincia di Cremona; sempre nel 1937 dal comune di Turano Lodigiano vennero staccate, una zona di territorio disabitata, aggregata al comune di Moscazzano e una zona di territorio aggregata al comune di Credera di Rubbiano. In seguito alla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1946 il comune di Turano Lodigiano veniva amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio, popolazione residente: abitanti 2281 (Censimento 1951), abitanti 1817 ( Censimento 1961), abitanti 1416 (Censimento 1971) nel 1971 il comune di Turano Lodigiano aveva una superficie di ettari 16.
********************************************************
Edifici storici
 La chiesa di Santa Maria Assunta
La chiesa di Santa Maria Assunta
La prima attestazione di un insediamento religioso a Turano risale al XIII secolo, quando la chiesa di Turano intitolata a Santa Maria Assunta fu tra le istituzioni ecclesiastiche lodigiane tassate dal papato nella “talia” del 1261, dove figurava sottoposta alla giurisdizione della pieve di Cavenago d’Adda (C.D. Laudese 1879-1885,II,354) Nel 1485 fu fondata la chiesa della Madonna Addolorata dove dal 1502 si insediò una comunità di Serviti, poi soppressa nel 1772 ( convento di San Lorenzo). Il 25 giugno 1505 la famiglia Mozzanica devolse un ricco lascito a beneficio del rettore secolare di Santa Maria Assunta (Agnelli 1917 a) Nel 1584 la chiesa di Santa Maria Assunta di Turano fu censita come parrocchia con il titolo di rettoria nel riordinamento della struttura territoriale ecclesiastica del lodigiano seguita al Concilio di Trento ( Chiese parrocchiali di Lodi 1584) La parrocchia di Turano nel 1619 figurava compresa nel vicariato di Cavenago d’Adda ed era officiata da un rettore; vi erano state istituite le confraternite del Santissimo Sacramento e della Dottrina Cristiana: la parrocchia contava 774 anime e comprendeva la chiesa del convento dei monaci Serviti ( descriptio 1619) Nel 1690 la parrocchia contava 650 anime e vi era stato eretto l’oratorio di S. Geronimo; Turano era compreso nel vicariato di Bertonico ( descriptio 1690) . Secondo la nota specifica delle esenzioni prediali a favore delle parrocchie dello Stato di Milano, la parrocchia di Turano possedeva fondi per pertiche 178,18 il numero delle anime conteggiato tra Pasqua del 1779 e quella del 1780, era di 790 ( nota parrocchie dello Stato di Milano, 1781). Nel 1786 Turano era compresa nel vicariato di Bertonico; il numero delle anime ammontava a 788 (Parrocchie 1786) Turano nel 1859 apparteneva al vicariato di Castiglione d’Adda, il diritto di nomina del parroco spettava alla famiglia Calderaia, contava 1100 anime e comprendeva l’oratorio di S. Gerolamo ( Stato del clero 1859) nel 1910 il numero delle anime ammontava a 1406; Turano era compreso nel vicariato di Castiglione d’Adda (Parrocchie 1910), la parrocchia di Turano Lodigiano nel 1989 era compresa nel vicariato di Casalpusterlengo (Guida diocesi Lodi 1987, Guida diocesi Lodi 1980).
 È la «sfera centrifuga centripeta», imponente struttura in marmo bianco di Carrara del diametro di 2,2 metri e del peso di 3 tonnellate, collocata nella piazza della chiesa dell' Assunta. Un dono per Turano Lodigiano, di Gert Marcus (artista di fama internazionale nato ad Amburgo nel 1914 e morto a Stoccolma nel 2008) realizzata nel 1972 e donata nel 2000 al comune di Turano Lodigiano frutto dell' amicizia che lega l' artista scandinavo al parroco, don Luigi Gatti, e a Guido Oldani, storico e poeta di Melegnano.
È la «sfera centrifuga centripeta», imponente struttura in marmo bianco di Carrara del diametro di 2,2 metri e del peso di 3 tonnellate, collocata nella piazza della chiesa dell' Assunta. Un dono per Turano Lodigiano, di Gert Marcus (artista di fama internazionale nato ad Amburgo nel 1914 e morto a Stoccolma nel 2008) realizzata nel 1972 e donata nel 2000 al comune di Turano Lodigiano frutto dell' amicizia che lega l' artista scandinavo al parroco, don Luigi Gatti, e a Guido Oldani, storico e poeta di Melegnano.
 purtroppo nel 2012 collassata su se stessa e andata totalmente distrutta.
purtroppo nel 2012 collassata su se stessa e andata totalmente distrutta.
In questa chiesa si può godere musiche dell'organo settecentesco di autore sconosciuto con interventi di Franceschini (1844) e Cesare Cavalli (tra XIX e XX secolo). Posto sopra l'ingresso principale; facciata composta da23 canne in stagno appartenenti al Principale 8' formanti un prospetto ad una cuspide con bocche delle canne allineate al labbro superiore a mitria. La nota prodotta dalla canna maggiore è il Do2; quella prodotta dalla canna minore è il Sib3 del Principale. Somiere maestro del tipo a tiro con 10 stecche e 45 ventilabri con borsini collocati all'interno della segreta. I tasti Do1 e Re1 sono collegati anche ai ventilabri Do2 e Re2. Tutti i registri di canne sul somiere maggiore cominciano dal Mi1. Collocazione a finestra per una tastiera scavezza di 47 tasti (Do1-Re5) con tasti diatonici ricoperti di bosso e cromatici in ebano. Pedaliera (ricostruita) a leggio di 18 pedali (Do1-La2); estensione reale del registro di pedale Do1-Si1.
Principale 8'
Ottava 4'
Quinta decima
Decima nona
Vigesima seconda
Vigesima sesta
Vigesima nona
Cornetta tre file
Flauto in XII
Voce Umana
Contrabbassi
Lo strumento è stato restaurato nel 2009 dalla Bottega Organaria di Cremonesi & D'Arpino di Soncino (CR)
Dopo il restauro negli anni dal 2009 al 2013 hanno avuto occasione di fare ascoltare le magiche sonorità di questo strumento nell'ambito dell'Autunno organistico Lodigiano promosso dall'Accademia Maestro Raro i maestri: Marco Rossi (2009), Enrico Viccardi (2010), Fabiana Ciampi (2011), Montserrat Torrent (2012), Jeremy Joseph (2013)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
La chiesa di Sant’Ilario a Melegnanello

Questa chiesa ha origini remote, ma il primo documento che riporta il suo nome è quello del 1261 quando dovette pagare, al notaio Guala, Legato Pontificio della Diocesi di Lodi, 12 denari imperiali. Nel 1526 l’intero edificio venne riedificato a spese di Alessandro Mezzani confermando il Jus Patronato che in precedenza era sempre stato della sua famiglia. Con il passaggio del feudo ai Visconti il patronato feudale venne a scomparire. Giungendo ai giorni nostri attraverso restauri e donazioni che hanno portato all’antico splendore il quadro di S. Ilario Vescovo, a cura della professoressa Conca di Lodi, al rifacimento della facciata, al restauro della parte decorativa e degli arredi, nel 1992 vi è stato collocato il nuovo altare di fronte ai fedeli e l’ambone, opere dell’artista Tuffetti Mario di Mozzanica (BG)

Anche in questa chiesa si può godere delle musiche dell'Organo del XIX secolo di anonimo, con intervento di Biroldi (1886). E' collocato in cantoria sopra l'ingresso principale. Facciata di 23 canne in una campata a cuspide; la canna maggiore è il La1 del Principale 8B. Una tastiera di 50 note da Do1 a Fa5 con prima ottava scavezza. Pedaliera a leggio di 18 note da Do1-Fa2 costantemente unita alla tastiera, con prima ottava cromatica; il Mi2 aziona la Terza Mano ed il Fa2 il Rollante. In basso a destra pedaloni per il Tiratutti e la Combinazione libera alla lombarda.
Principale 8 BII Principale 8 B
Tromba 8 S Principale 8 S
Fagotto B Ottava 4B
Flauto 8 S Ottava 4 S
Viola 4 B Decima V2
Flauto 4 S Decima nona
Ottavino 2 S Vigesima seconda
Cornetto due file S Vigesima sesta e nona
Voce Umana Bombarda 16
Fisarmonica Contrabbasso 16 e rinforzi
Negli anni dal 2004 al 2013 hanno avuto occasione di fare ascoltare le magiche sonorità di questo strumento nell'ambito dell'Autunno organistico Lodigiano, promosso dall'Accademia Maestro Raro; i maestri: Enrico Viccardi (2004) Lidia Cremona (2005), Matteo Golizio (2006), Alessandro Rizzotto (2007), Francesco Saverio Pedrini (2008) Simone Quaroni (2010).
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Palazzo Calderari www.palazzocalderari.it/ <---clicca qui di fianco x Tutte le notizie relative al Palazzo
www.palazzocalderari.it/ <---clicca qui di fianco x Tutte le notizie relative al Palazzo
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Cascina Braglia Il nome di origine celtica indicava casa di abitazione con terre fruttifere. La posizione del complesso dà la sensazione, di essere un luogo da cui si domina il territorio circostante può essere considerato tra i luoghi più antichi di Turano in cui erano insediati i Celti, nei secoli passò ai Mozzanica che nel 1485 fecero erigere il Monastero di San Lorenzo dei Padri Serviti di Maria. E’ da considerarsi una delle cascine monumentali del Lodigiano. La mappa catastale del 1723 mostra che a quella data era già presente una cascina sul sito dell'attuale; il complesso, denominato nei registri catastali "casa da massaro", è rappresentato come un singolo lotto (indicativo forse sia dei fabbricati che degli spazi cortilizi) di forma molto articolata, circondato da tre piccoli orti e, a nord, da un grande giardino . I confini nord ed est coincidono con buona approssimazione con i fronti con medesimo orientamento della casa padronale e dei corpi annessi attuali il muro di cinta che oggi delimita la proprietà a sud est è allineato con la strada d'ingresso settecentesca e con il confine sud est del lotto. A sud nella mappa è indicato un aggetto; oggi ha l'orientamento del confine est del lotto in questa parte l'arcone di ingresso alla cascina, che appare però traslato di qualche metro a ovest rispetto al confine stesso Il 9 agosto 1828 la cascina, rimasta di proprietà di Vittoria Peluso vedova Calderara, veniva assegnata per morte di quest'ultima alle sue sorelle Teresa Peluso Vassalli e Giuseppa Peluso Cima e alle nipoti Vittoria Peluso Crivelli e Benedetta Peluso Martignoni. Nel 1833 fu steso un atto di divisione, con cui le sorelle Peluso superstiti si spartirono i beni. Con l'atto, rogato il 14 maggio dal notaio Giuseppe Arpegiani di Milano, l'edificio, definito "cassina detta la Brajla, giardino unito e orto de' pigionanti", fu assegnato a Giuseppa Peluso Cima. Il 18 febbraio 1866 la cascina fu intestata al dott. fisico Carlo Premoli del fu Francesco in seguito all'atto di acquisto rogato in data 16 dicembre 1865 dal notaio Settimio Crociolani di Lodi (al n. 1497 del suo repertorio).La mappa catastale del 1867 permette di riscontrare con maggior precisione la corrispondenza tra l'attuale casa padronale con gli annessi fabbricati a est e a ovest (ma il muro di cinta della proprietà ne ricalca il sito. La cascina appare inoltre ampliata a sud con la costruzione di un nuovo fabbricato (probabilmente una stalla, date le dimensioni) oltre il quale si estende un secondo cortile, e con un lungo corpo di fabbrica ortogonale al fronte sud della casa padronale, innestatato all'estremità ovest del fabbricato. Entrambi non esistono più. A questa data invece anche gli annessi alla casa padronale esistono per certo. La mappa catastale del 1897 documenta l'ulteriore ampliamento dei rustici della cascina: il corpo di fabbrica sul confine ovest dell'aia (non più esistente) appare prolungato in direzione sud; a sud della stalla (?) edificata entro il 1867 sono indicati due nuovi corpi di fabbrica rettangolari ad essa paralleli, il primo dei quali tuttora esistente. La cascina risulta appartenere ancora nel 1887 a Carlo Premoli del fu Francesco
Il nome di origine celtica indicava casa di abitazione con terre fruttifere. La posizione del complesso dà la sensazione, di essere un luogo da cui si domina il territorio circostante può essere considerato tra i luoghi più antichi di Turano in cui erano insediati i Celti, nei secoli passò ai Mozzanica che nel 1485 fecero erigere il Monastero di San Lorenzo dei Padri Serviti di Maria. E’ da considerarsi una delle cascine monumentali del Lodigiano. La mappa catastale del 1723 mostra che a quella data era già presente una cascina sul sito dell'attuale; il complesso, denominato nei registri catastali "casa da massaro", è rappresentato come un singolo lotto (indicativo forse sia dei fabbricati che degli spazi cortilizi) di forma molto articolata, circondato da tre piccoli orti e, a nord, da un grande giardino . I confini nord ed est coincidono con buona approssimazione con i fronti con medesimo orientamento della casa padronale e dei corpi annessi attuali il muro di cinta che oggi delimita la proprietà a sud est è allineato con la strada d'ingresso settecentesca e con il confine sud est del lotto. A sud nella mappa è indicato un aggetto; oggi ha l'orientamento del confine est del lotto in questa parte l'arcone di ingresso alla cascina, che appare però traslato di qualche metro a ovest rispetto al confine stesso Il 9 agosto 1828 la cascina, rimasta di proprietà di Vittoria Peluso vedova Calderara, veniva assegnata per morte di quest'ultima alle sue sorelle Teresa Peluso Vassalli e Giuseppa Peluso Cima e alle nipoti Vittoria Peluso Crivelli e Benedetta Peluso Martignoni. Nel 1833 fu steso un atto di divisione, con cui le sorelle Peluso superstiti si spartirono i beni. Con l'atto, rogato il 14 maggio dal notaio Giuseppe Arpegiani di Milano, l'edificio, definito "cassina detta la Brajla, giardino unito e orto de' pigionanti", fu assegnato a Giuseppa Peluso Cima. Il 18 febbraio 1866 la cascina fu intestata al dott. fisico Carlo Premoli del fu Francesco in seguito all'atto di acquisto rogato in data 16 dicembre 1865 dal notaio Settimio Crociolani di Lodi (al n. 1497 del suo repertorio).La mappa catastale del 1867 permette di riscontrare con maggior precisione la corrispondenza tra l'attuale casa padronale con gli annessi fabbricati a est e a ovest (ma il muro di cinta della proprietà ne ricalca il sito. La cascina appare inoltre ampliata a sud con la costruzione di un nuovo fabbricato (probabilmente una stalla, date le dimensioni) oltre il quale si estende un secondo cortile, e con un lungo corpo di fabbrica ortogonale al fronte sud della casa padronale, innestatato all'estremità ovest del fabbricato. Entrambi non esistono più. A questa data invece anche gli annessi alla casa padronale esistono per certo. La mappa catastale del 1897 documenta l'ulteriore ampliamento dei rustici della cascina: il corpo di fabbrica sul confine ovest dell'aia (non più esistente) appare prolungato in direzione sud; a sud della stalla (?) edificata entro il 1867 sono indicati due nuovi corpi di fabbrica rettangolari ad essa paralleli, il primo dei quali tuttora esistente. La cascina risulta appartenere ancora nel 1887 a Carlo Premoli del fu Francesco
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Cascina La Grande a Melegnanello Un complesso del XVIII - XX secolo che già dal nome fa capire immediatamente quale rilevanza rivestisse sul territorio, posta proprio al centro di Melegnanello, il confronto con il cimitero di Melegnanello, che è nell’angolo in alto a sinistra, quel quadratino biancheggiante, in questa immagine aerea (Google Earth) dà una idea della sua grandezza. La mappa catastale del 1722 mostra che a quella data era già presente una cascina sul sito dell'attuale; il complesso, denominato nei registri catastali "casa da massaro", era a corte chiusa e occupava un lotto quadrangolare poco più piccolo dell'attuale sito della cascina. I confini est (con la strada) e sud coincidevano con gli attuali. La cascina, apparteneva al marchese Antonio Calderara fu Bartolomeo, misurava 25 pertiche e 8 tavole ed era stimata valere 215 scudi e 2 lire. Attualmente sul sito della cascina settecentesca sono il porticato d'ingresso, che però non presenta particolarità utili a darne una datazione, e in parte la stalla, che tuttavia è senz'altro più recente ed ha un differente ingombro rispetto alle preesistenze settecentesche.
Un complesso del XVIII - XX secolo che già dal nome fa capire immediatamente quale rilevanza rivestisse sul territorio, posta proprio al centro di Melegnanello, il confronto con il cimitero di Melegnanello, che è nell’angolo in alto a sinistra, quel quadratino biancheggiante, in questa immagine aerea (Google Earth) dà una idea della sua grandezza. La mappa catastale del 1722 mostra che a quella data era già presente una cascina sul sito dell'attuale; il complesso, denominato nei registri catastali "casa da massaro", era a corte chiusa e occupava un lotto quadrangolare poco più piccolo dell'attuale sito della cascina. I confini est (con la strada) e sud coincidevano con gli attuali. La cascina, apparteneva al marchese Antonio Calderara fu Bartolomeo, misurava 25 pertiche e 8 tavole ed era stimata valere 215 scudi e 2 lire. Attualmente sul sito della cascina settecentesca sono il porticato d'ingresso, che però non presenta particolarità utili a darne una datazione, e in parte la stalla, che tuttavia è senz'altro più recente ed ha un differente ingombro rispetto alle preesistenze settecentesche.
Il 9 agosto 1828 la cascina, rimasta di proprietà di Vittoria Peluso vedova Calderara, veniva assegnata per morte di quest'ultima alle sue sorelle Teresa Peluso Vassalli e Giuseppa Peluso Cima e alle nipoti Vittoria Peluso Crivelli e Benedetta Peluso Martignoni Nel 1833 fu steso un atto di divisione, con cui le sorelle Peluso superstiti si spartirono i beni. Con l'atto, rogato l'otto febbraio dal notaio Giuseppe Arpegiani di Milano, l'edificio, definito "cassina detta di Melegnanello con casa da piggionanti e fittabile", fu assegnato a Giuseppa Peluso Cima Il 22 luglio 1843 tutta la partita intestata a Giuseppa Peluso Cima in Melegnanello viene trasferita a Pietro Negroni del fu Giovanni in seguito all'acquisto effettuato in data 20 giugno 1843 con rogito del notaio Achille Marocco di Milano. Il 15 agosto 1856 i beni del Negroni vengono dichiarati eredità giacente in seguito alla morte dello stesso avvenuta in data 14 giugno 1856. Solo il 9 luglio 1857 vengono intestati a Carlo Negroni del fu Giovanni e Giovanni Battista Negroni del fu Giuseppe in parti uguali. La mappa catastale del 1867 attesta la permanenza del portico su strada , forse ristrutturato nel corso del tempo, e l'avvenuta edificazione della stalla ad esso adiacente che chiude a sud la corte. E' riconoscibile anche la casa padronale, il cui ingombro coincide sostanzialmente con l'attuale (oggetto tuttavia senz'altro di una successiva ristrutturazione).La mappa catastale del 1897 documenta l'avvenuta edificazione della stalla dei cavalli sita nella zona ovest della corte e di un rustico con forma a pettine a nord di questa, tuttora esistente ma rimaneggiato, del quale doveva fare parte il piccolo corpo di fabbrica (probabilmente una porcilaia), che oggi appare isolato. Quest'ultimo presenta elementi decorativi molto simili a quelli della stalla dei cavalli e potrebbe essere coevo ad essa. La cascina risulta intestata nel 1888 a Carlo Negroni, figlio del fu Giovanni.
La casa padronale, pur conservando tuttora l'ingombro in pianta di quella costruita entro il 1867, appare essere stata ristrutturata in epoca più recente. In particolare la facciata est è stata "nobilitata" dall'aggiunta di lesene ioniche di ordine gigante, di un portico su eleganti pilastrini sormontato da terrazza e di una balaustra posta sopra la grondaia del tetto, con funzione prettamente decorativa. I particolari architettonici e i materiali impiegati inducono a datare l'intervento ai primi decenni del Novecento, in ambito culturale eclettico.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Cascina Mairaga,  ingresso alla corte
ingresso alla corte La mappa catastale del 1723 mostra che a quella data era già presente una cascina sul sito dell'attuale; il complesso, denominato nei registri catastali "casa da massaro". La corte su cui si articola oggi la cascina conserva pressoché invariata la forma del lotto settecentesco, ad eccetto della zona nord est, dove nel 1723 era una lunga appendice dove invece oggi la corte si ferma. La mappa al solito non riporta il tracciato degli edifici che occupavano l'appezzamento. Gli edifici che compongono oggi la cascina sono probabilmente per lo più ottocenteschi, ma non è escluso che almeno in parte ricalchino il sito di preesistenze del secolo precedente. L'edificio posto a ovest dell'arco di ingresso alla corte, forse una ex casara, con la parete nord ritmata da grossi contrafforti, potrebbe essere piuttosto vecchio, come pure il piccolo fabbricato a due piani.
La mappa catastale del 1723 mostra che a quella data era già presente una cascina sul sito dell'attuale; il complesso, denominato nei registri catastali "casa da massaro". La corte su cui si articola oggi la cascina conserva pressoché invariata la forma del lotto settecentesco, ad eccetto della zona nord est, dove nel 1723 era una lunga appendice dove invece oggi la corte si ferma. La mappa al solito non riporta il tracciato degli edifici che occupavano l'appezzamento. Gli edifici che compongono oggi la cascina sono probabilmente per lo più ottocenteschi, ma non è escluso che almeno in parte ricalchino il sito di preesistenze del secolo precedente. L'edificio posto a ovest dell'arco di ingresso alla corte, forse una ex casara, con la parete nord ritmata da grossi contrafforti, potrebbe essere piuttosto vecchio, come pure il piccolo fabbricato a due piani.
Il 9 agosto 1828 la cascina, rimasta di proprietà di Vittoria Peluso vedova Calderara, veniva assegnata per morte di quest'ultima alle sue sorelle Teresa Peluso Vassalli e Giuseppa Peluso Cima e alle nipoti Vittoria Peluso Crivelli e Benedetta Peluso Martignoni. Nel 1833 fu steso un atto di divisione, con cui le sorelle Peluso superstiti si spartirono i beni. Con l'atto, rogato il 14 maggio dal notaio Giuseppe Arpegiani di Milano, l'edificio, denominato "possessione la Majraga", fu assegnato a Teresa Peluso maritata Vassalli. Il 26 ottobre 1840, in seguito alla morte di Teresa Peluso Vassalli avvenuta il giorno 8 agosto, la cascina veniva intestata all'eredità giacente di Peluso, amministrata da don Carlo Vassalli, e ad Elisa Gesnelle maritata Duclos e Gio Gesnelle; quindi, il 26 maggio 1841, a Peluso Francesco e Vittoria per metà e Elisa Gesnelle per l'altro metà.Il 30 gennaio 1849 la cascina fu intestata ai nobili Francesco Peluso, Benedetta Peluso maritata Martignoni, e Vittoria Pelsuso maritata Crivelli Visconti, fratello e sorelle, in comune, in seguito alla divisione tra gli eredi di Vittoria Calderara fatta dgli ing. Stoppani e Cadoretti il 20/3/1846 e depositata presso il notaio Giuseppe Velini di Milano (atto 5 maggio 1846). Nell'atto la cascina è descritta analiticamente. A nord era l'andito d'ingresso, probabilmente quello tuttora esistente, con accanto un portico a sei campate con granaio superiore. Presso il portico era la casera, col "casirolo del sale"; quindi la casa del fittabile, con sala, saletta, cucina, forno, cantina e stanze superiori, in parte sopra ad un portico, e sottotetto (granaio). Seguiva a ovest il "casello per la produzione del formaggio". A ovest della corte erano dei porcili (non più esistenti), e quindi un arsenale, una tinaia, dei pollai. C'era poi un portico a 17 campate sul quale si aprivano le stalle.
L'otto maggio 1849 la cascina veniva intestata all'ing. Antonio, a don Carlo e a Luigi Premoli, fratelli, figli del fu Francesco, per acquisto, come da atto in data 6 marzo 1849 n. 3112 del notaio Giuseppe Velini di Milano. L'otto maggio 1862 la cascina passava al dr. Carlo Premoli del fu Francesco per divisione, come da atto in data 25 marzo 1862 rogato da Pietro Commizzoli, notaio di Lodi. La mappa catastale del 1897 mostra la cascina con una consistenza (in pianta) quasi identica a quella di trent'anni prima e molto simile all'attuale. L'unica novità di rilievo consiste nella presenza di un nuovo fabbricato lungo il confine sud della corte, sul sito dell'ala sud del portico.
Il portico è però oggi un corpo continuo a L ed è possibile che con la successiva demolizione della piccola corte quadrata a sud est, l'ala ovest della stessa sia stata ricostruita riconnettendola al portico di recente costruzione. La cascina nel 1887 apparteneva a Carlo Premoli del fu Francesco sul viale d’accesso si possono vedere due leoni in pietra, dei quattro, che precedentemente ornavano il ponte sulla Muzza sul viale che portava da Palazzo Calderari a Melegnanello,

gli altri due, non si sa perchè, furono portati a Ospedaletto Lodigiano e messi all’ingresso della strada per cascina Villafranca di mezzo( Griona) detta da allora “Cascina dei due leoni”
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Cascina Robecco Questo insediamento ha origini antichissime, di cui non si trova traccia se non a partire dal 1290 in un documento di investitura vescovile, in un altro documento conservato nell’Archivio delle Monache di S. Chiara Vecchia del 1309 è nominato il Lago di Ribecco, quale probabile palude o acquitrino formato in quella zona dalle esondazioni dell’Adda, o dai resti di quello che era il lago Gerundo. In altri documenti risulta che fu saccheggiato nel 1483 dai Cremaschi assieme alle località di Belvignate. Cascina delle Donne, e Cavenago e di nuovo il 29 aprile del 1509 Robecco venne saccheggiato e rapinato del bestiame e portati a Crema alcuni prigionieri.
Questo insediamento ha origini antichissime, di cui non si trova traccia se non a partire dal 1290 in un documento di investitura vescovile, in un altro documento conservato nell’Archivio delle Monache di S. Chiara Vecchia del 1309 è nominato il Lago di Ribecco, quale probabile palude o acquitrino formato in quella zona dalle esondazioni dell’Adda, o dai resti di quello che era il lago Gerundo. In altri documenti risulta che fu saccheggiato nel 1483 dai Cremaschi assieme alle località di Belvignate. Cascina delle Donne, e Cavenago e di nuovo il 29 aprile del 1509 Robecco venne saccheggiato e rapinato del bestiame e portati a Crema alcuni prigionieri.
Da un documento del 16 novembre 1559 risulta essere proprietà del nobile Giovanni Francesco Vignati, nel 1657 venne infeudato alla famiglia Trivulzi, passò poi ai Conti Bolagnos; con la creazione del Regno d’Italia e le nuove disposizioni amministrative nel 1869 fu aggregato a Turano. La mappa catastale del 1723 permette di verificare che a questa data il nucleo abitato di Robecco, a quest'epoca comune indipendente, sorgeva sul sito della cascina attuale. Non è possibile tuttavia trovare alcuna corrispondenza tra l'attuale disposizione dei fabbricati nella cascina e quella dell'insediamento più antico. Robecco aveva infatti due corti rurali, la seconda dotata di un piccolo oratorio posto sulla strada per Belvignate; vi erano inoltre alcuni singoli edifici indipendenti: una casa a nord delle due corti e altri due corpi di fabbrica a sud della strada citata. L'attuale cascina presenta invece un impianto a corte chiusa quadrangolare molto regolare, la cui ampiezza, da ovest a est, corrisponde a quella della corte, ma che si sviluppa di fatto su uno spazio che prende parte di entrambe le corti settecentesche.
Nel 1723 la corte maggiore, definita "casa da massaro", apparteneva ai Padri Barnabiti. Nel 1816 tutti i beni "del soppresso collegio de' Padri Barnabiti di S. Giovanni alle Vigne in Lodi" già confiscati dal Demanio Regio venivano messi all'asta. La contessa Vittoria Calderara Pino si aggiudicava per 42.000 lire la possessione di Robecco con la cascina (atto notarile rogato da Gio Batta Giudici in data 19 novembre 1816). La nuova proprietaria viene registrata negli atti catastali il 14 gennaio 1817. Poiché la contessa, vedova del conte Bartolomeo Calderara, era ancora proprietaria anche della corte, con questo acquisto si ponevano le premesse per la radicale ristrutturazione della cascina, con la creazione di una sola grande corte unitaria sul sito delle due. Il 9 agosto 1828 il complesso di proprietà di Vittoria Peluso vedova Calderara veniva assegnato per morte di quest'ultima alle sue sorelle Teresa Peluso Vassalli e Giuseppa Peluso Cima e alle nipoti Vittoria Peluso Crivelli e Benedetta Peluso Martignoni. Nel 1833 fu steso un atto di divisione, con cui le sorelle Peluso superstiti si spartirono i beni. Con l'atto, rogato il 14 maggio dal notaio Giuseppe Arpegiani di Milano, la cascina fu assegnata alla marchesa Giuseppa Peluso maritata Cima.
Il 24 ottobre 1866 la cascina Robecco fu intestata a Enrico Pecchi del fu Agostino in seguito all'acquisto avvenuto in data 29 gennaio 1866 (atto n. 1524 rogato dal notaio Settimo Crociolani di Lodi).La mappa catastale del 1897 mostra la cascina con un impianto quasi del tutto immutato rispetto a quello di trent'anni prima (che doveva essere comunque il frutto di lavori recenti). Solo il profilo in pianta della grande stalla edificata sul lato nord appare leggermente murato e perfettamente coincidente con l'attuale, essendo stato probabilmente effettuato un leggero amplimanto o una ristrutturazione. Mutato è anche il disegno del fronte est, che tuttavia appare oggi del tutto rinnovato rispetto a quello che doveva essere l'aspetto tardo ottocentesco. Nel 1888 la cascina apparteneva ai fratelli e sorelle Pecchi del fu Enrico e alla vedova Annunciata Ranza in Pecchi.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Cascina delle Donne,  Sorge sullo spalto dell’antico paleoalveo dell’Adda in posizione dominante su tutto il territorio circostante da cui il toponimo “supra ripe” ( somma riva) è questa l’antica Corte Sommaria. Il 1 aprile 1142 questo luogo fu dato in pegno ad Uberto de’ Casetti da Giovanni, vescovo di Lodi a cui era stato dato dai Milanesi, per far fronte ai costi che stavano conducendo contro Como.Il 15 giugno 1156 Lanfranco da Cassino Vescovo di Lodi successore di Uberto de’ Casetti , investiva di questi beni un certo Obizzone Notta, il 24 settembre 1164 l’Imperatore Federico Barbarossa avendo sotto la sua protezione il vescovo di Lodi e tutta la chiesa lodigiana confermò a titolo di feudo molti luoghi del lodigiano tra cui anche Corte Sommariva, nel 1167 furono investiti di questo luogo i Capitanei di Merlino, potentissimi signori del lodigiano; il 21 maggio 1299 il Vescovo di Lodi Bernerdo Talente alfine di far fronte alle necessità economiche dell’Episcopato affittò ad Antonio Fissiraga, di Lodi, molti beni tra cui le terre di Corte Sommariva. il 12 febbraio 1309 Antonio Fissiraga cambiò con il Vescovo Egidio Dell’Acqua, alcune proprietà al fine di tenere per se altri luoghi tra cui la corte e attraverso la moglie Palatina Tresseni ne dotò il Monastero di Santa Chiara Vecchia in Lodi. per secoli così Corte Sommariva divenne proprietà delle Monache di Santa Chiara, nel 1483 il luogo fu saccheggiato dalle incursioni oltre Adda dei cremaschi, poi sia gli avvenimenti sia eventi naturali erosioni e delle esondazioni dell’Adda, ne distrussero gli antichi edifici e il cascinale che man mano venne costruito assunse il nome di Cascina delle Donne dettato dal fatto che la proprietà era delle Monache di Santa Chiara.
Sorge sullo spalto dell’antico paleoalveo dell’Adda in posizione dominante su tutto il territorio circostante da cui il toponimo “supra ripe” ( somma riva) è questa l’antica Corte Sommaria. Il 1 aprile 1142 questo luogo fu dato in pegno ad Uberto de’ Casetti da Giovanni, vescovo di Lodi a cui era stato dato dai Milanesi, per far fronte ai costi che stavano conducendo contro Como.Il 15 giugno 1156 Lanfranco da Cassino Vescovo di Lodi successore di Uberto de’ Casetti , investiva di questi beni un certo Obizzone Notta, il 24 settembre 1164 l’Imperatore Federico Barbarossa avendo sotto la sua protezione il vescovo di Lodi e tutta la chiesa lodigiana confermò a titolo di feudo molti luoghi del lodigiano tra cui anche Corte Sommariva, nel 1167 furono investiti di questo luogo i Capitanei di Merlino, potentissimi signori del lodigiano; il 21 maggio 1299 il Vescovo di Lodi Bernerdo Talente alfine di far fronte alle necessità economiche dell’Episcopato affittò ad Antonio Fissiraga, di Lodi, molti beni tra cui le terre di Corte Sommariva. il 12 febbraio 1309 Antonio Fissiraga cambiò con il Vescovo Egidio Dell’Acqua, alcune proprietà al fine di tenere per se altri luoghi tra cui la corte e attraverso la moglie Palatina Tresseni ne dotò il Monastero di Santa Chiara Vecchia in Lodi. per secoli così Corte Sommariva divenne proprietà delle Monache di Santa Chiara, nel 1483 il luogo fu saccheggiato dalle incursioni oltre Adda dei cremaschi, poi sia gli avvenimenti sia eventi naturali erosioni e delle esondazioni dell’Adda, ne distrussero gli antichi edifici e il cascinale che man mano venne costruito assunse il nome di Cascina delle Donne dettato dal fatto che la proprietà era delle Monache di Santa Chiara.
Nel 1782 il monastero di Santa Chiara venne soppresso e tutti i beni furono venduti. Nel registro del monastero di S. Chiara Vecchia di Lodi si trova una descrizione dei beni della possessione "Cassinarum de Donne de Cavenago" del 1475. La cascina comprendeva allora diversi edifici: una casa con quattro camere coperta da tetto in coppi, con accostata una "caminata" e un portico. Due portici di due campate con tetti in coppi e un portichetto contiguo su pilastri. Un forno con portichetto antistante coperto da tetto in coppi. Un locale con copertura di paglia, che era usato per la salatura (del formaggio?). Una "cassina" di quattro campate con tetto in coppi su pilastri ed una seconda con una stalla nella parte inferiore. Infine una casa con tetto in coppi , nuova, a due piani, con portichetto annesso. E' impossibile stabilire alcun rapporto tra questa descrizione e il bene oggi esistente ma pare del tutto plausibile che la cascina fosse già sul sito dell'attuale. L'atto documenta inoltre che fin dal XV secolo la denominazione di Cassina delle Donne ...In uno dei tanti contratti d'affitto della cascina stipulati dalle monache, datato 26 gennaio 1600, si specifica che occorrendo costruire edifici sulla possessione della cascina delle Donne o compiere altri lavori "pertinenti alle case, cassine et molino" il materiale sarebbe stato fornito dai fittabili, e solo nell'arco di due anni le monache l'avrebbero rimborsato; in cambio però il monastero si obbligava a fare "accomodare il torchio che possi lavorare da vino et oglio, et la pesta del riso quanto prima". Dunque a quest'epoca la cascina era dotata senz'altro di un mulino con torchio e ruote per la pilatura del riso; è probabile che si tratti dell'edificio posto poco a nord della casa padronale, dove la roggia Tibera compie un angolo retto, che tuttora scavalca in parte la roggia e che documenti più tardi (1732) denominano "torchio".La mappa catastale del 1723 permette di verificare con precisione quale era il sito effettivamente occupato dalla cascina a questa data e di avere un'immagine precisa della sua consistenza edilizia. La cascina si presenta con un aspetto molto simile all'attuale dal punto di vista tipologico: è un complesso di piccoli edifici isolati prossimi tra loro, che solo nella parte sud tendono a delimitare una corte chiusa. Il complesso è delimitato a nord e a est dalla strada per Cavenago, e ad ovest, per un tratto, dalla roggia Tibera. Nella zona sud è una grande corte delimitata da tre lunghi corpi di fabbrica, e dotata di un ingresso da sud, nei pressi dei quali sorge l'oratorio di S. Chiara (parte definita "casa da massaro" nei registri catastali del 1723). Di questa prima corte esiste oggi solo l'oratorio; la casa padronale A e l'edificio adiacente a nord mantengono l'allinemento del fabbricato che nel 1723 chiudeva a ovest il cortile.
All'inizio del XIX secolo il monastero di S. Chiara vecchia di Lodi veniva soppresso. Nel 1804 la cascina, nel frattempo diventata parte del comune di Robecco (cui era stato annesso quello di Cassina delle Donne) veniva intestata a Giovanni Adamo Kramer del fu Giovanni, l'ultimo livellario del soppresso monastero, che aveva acquistato all'asta il bene, come da rogito in data 27/10/1804 del notaio Alessandro Bellavita di Lodi.Nel 1815 la cascina veniva intestata a Carlo Andrea, Francesco, Ferdinando ed Antonio Kramer, figli del fu Carlo Adamo e alle sorelle Maria Carolina Luigia ed Amalia, a causa della morte del padre il avvenuta il 22 aprile 1815 e in conformità al testamento dello stesso (13/6/1814 consegnato al notaio Giorgio Sacchi di Milano). Il successivo otto luglio il notaio Francesco Maderna di Milano rogava le rinunce delle sorelle al bene in favore dei fratelli. Il 13 settembre 1844 la cascina veniva intestata ai soli Francesco, Ferdinando ed Antonio Kramer figli del fu Gio Adamo per rinucia da parte di Carlo Andrea Kramer in favore dei suoi fratelli. Il 5 settembre 1854 la cascina veniva intestata solo ai due fratelli Francesco e Ferdinando Kramer del fu Gio Adamo.Il 24 aprile 1862 la cascina restava intestata a solo uno dei fratelli Kramer figli del fu Gio Adamo Francesco, In seguito alla morte di Francesco Kramer, avvenuta in data 1/8/1866 e in conformità al suo testamento olografo3/3/1866 (atto di apertura 4/8/1866 n. 4535 del notaio Pharisen di Milano), il primo novembre 1866 la cascina veniva assegnata all'ing. Edoardo Kramer del fu Carlo Andrea, nipote di Francesco. La mappa catastale del 1897 mostra la cascina con un impianto, nella zona nord, quasi identico all'attuale. Risultano infatti essere state edificate le case coloniche poste a delimitare a ovest e a nord la corte dei lavoratori salariati. Al centro della corte sono due piccoli fabbricati che erano senz'altro di servizio, sostuiti più tardi da un corpo di fabbrica unico di servizio che occupa anche il sito dei fabbricati preesistenti. L'edificio che era prossimo al gomito formato dalla strada a nord est risulta demolito, mentre permane immutato l'edificio a est della stessa strada. A nord, l'edificio sul canale colatore è affiancato da un secondo corpo, oggi non più esistente; entrambi sono classificati nel 1887 come "fabbricati per azienda rurale". La corte sud e il mulino sulla roggia Tibera (accatastato come "pila da riso e torchio da olio ad acqua"). Gli edifici che sorgono sulla corte sud della cascina, oggi assai meno unitaria che nel Settecento e nell'Ottocento, sono in buona parte stati edificati dopo il 1897. La casa padronale, che presenta motivi decorativi liberty, potrebbe risalire al primo decennio del sec. XX; le stalle e i portici devono essere stati edificati più o meno nella stessa epoca, o comunque all'incirca entro i primi tre decenni del secolo, viste le tecniche costruttive tradizionali adottate. Più difficile è datare l'edificio a nord della casa padronale, che presenta un portico a T apparentemente ottocentesco, e una casa a due piani, priva di particolari elementi che ne consentano la datazione
 Nel mese di agosto 2012 Ottorino Buttarelli, ex preside dell’istituto agrario di Codogno e da sempre appassionato d’arte, ispirato «dalla bellezza del posto e della chiesa, che ha le fattezze di una piccola costruzione umbra ». Tanto che anche Il parroco di Cavenago d’Adda don Giampiero Marchesini, non a caso, la chiami familiarmente «la Porziuncola » del Lodigiano, richiamando il santuario alle porte di Assisi dove morì San Francesco e Santa Chiara abbracciò «sorella povertà », Ha realizzato una
Nel mese di agosto 2012 Ottorino Buttarelli, ex preside dell’istituto agrario di Codogno e da sempre appassionato d’arte, ispirato «dalla bellezza del posto e della chiesa, che ha le fattezze di una piccola costruzione umbra ». Tanto che anche Il parroco di Cavenago d’Adda don Giampiero Marchesini, non a caso, la chiami familiarmente «la Porziuncola » del Lodigiano, richiamando il santuario alle porte di Assisi dove morì San Francesco e Santa Chiara abbracciò «sorella povertà », Ha realizzato una  mezzaluna in terracotta con l’immagine di Santa Chiara e il Crocifisso, incastonata sopra il portale d’ingresso della chiesa di Cascina Delle Donne a Turano. Per realizzare la formella Buttarelli ha impiegato tre mesi e una volta pronta ha voluto che fosse cotta nell’Antica Fornace di Milano in funzione dal 1400. La mezzaluna dove è ora sistemata la terracotta probabilmente in passato conteneva un affresco o una statua. L’ampiezza del vano non lascia dubbi al riguardo. Ma risalire all’originario manufatto è difficile, poiché l’Angelo della Storia ha già cambiato più volte il volto di questo luogo ameno a due passi dall’Adda. In principio la chiesa faceva parte del convento delle Clarisse risalente al 1200, mentre oggi al suo posto sorge la cascina della famiglia Barbieri. Di particolare pregio sono «l’abside con decorazione barocca e l’altare ligneo» precisa Buttarelli. L’occasione per visitarla è quando verrà celebrata la Santa Messa per la festa di Santa Chiara e il 4 ottobre in cui si ricorda San Francesco. Ma la chiesa è aperta anche tutto il Mese Mariano
mezzaluna in terracotta con l’immagine di Santa Chiara e il Crocifisso, incastonata sopra il portale d’ingresso della chiesa di Cascina Delle Donne a Turano. Per realizzare la formella Buttarelli ha impiegato tre mesi e una volta pronta ha voluto che fosse cotta nell’Antica Fornace di Milano in funzione dal 1400. La mezzaluna dove è ora sistemata la terracotta probabilmente in passato conteneva un affresco o una statua. L’ampiezza del vano non lascia dubbi al riguardo. Ma risalire all’originario manufatto è difficile, poiché l’Angelo della Storia ha già cambiato più volte il volto di questo luogo ameno a due passi dall’Adda. In principio la chiesa faceva parte del convento delle Clarisse risalente al 1200, mentre oggi al suo posto sorge la cascina della famiglia Barbieri. Di particolare pregio sono «l’abside con decorazione barocca e l’altare ligneo» precisa Buttarelli. L’occasione per visitarla è quando verrà celebrata la Santa Messa per la festa di Santa Chiara e il 4 ottobre in cui si ricorda San Francesco. Ma la chiesa è aperta anche tutto il Mese Mariano
"""""""""""""""""""""""""""""""""
Cascina San Lorenzo

 Prende il nome dal Conte Lorenzo Mozzanica feudatario di Turano che nel 1485 fece erigere qui il Monastero dei Padri Serviti di Maria. i monaci ne presero possesso il 2 maggio 1502 e vi rimasero fino al 1772 quando l’ordine fu soppresso e il Monastero fu trasformato in cascinale. in seguito la vecchia chiesa profanata e distrutta fu in parte inglobata nel palazzo della casa padronale che si erge sulla parte più elevata della cascina. dal 1970 la cascina è disabitata e da allora l’incuria e il tempo ne hanno pian piano ridotto gli edifici in rovina. poco rimane dell’antica grande cascina. da ritenersi una delle cascine monumentali del Lodigiano.
Prende il nome dal Conte Lorenzo Mozzanica feudatario di Turano che nel 1485 fece erigere qui il Monastero dei Padri Serviti di Maria. i monaci ne presero possesso il 2 maggio 1502 e vi rimasero fino al 1772 quando l’ordine fu soppresso e il Monastero fu trasformato in cascinale. in seguito la vecchia chiesa profanata e distrutta fu in parte inglobata nel palazzo della casa padronale che si erge sulla parte più elevata della cascina. dal 1970 la cascina è disabitata e da allora l’incuria e il tempo ne hanno pian piano ridotto gli edifici in rovina. poco rimane dell’antica grande cascina. da ritenersi una delle cascine monumentali del Lodigiano.
La statua di S. Lorenzo come si presenta oggi 23 febbraio 2018 presso i ruderi di quello che fu il Convento di S. Lorenzo
Nel 1833 fu steso un atto di divisione, con cui le sorelle Peluso, eredi di Vittoria Peluso in Calderara, a sua volta sopravvissuta al marito Bartolomeo Calderari, si spartirono i beni ereditati fin dal 1828. Nell'atto, rogato il 14 maggio dal notaio Giuseppe Arpegiani di Milano, troviamo citato anche il "corpo di case da piggionanti a S.t Lorenzo ed orti" che faceva parte della possessione di cascina Braglia (assai prossima). Il complesso fu assegnato a Giuseppa Peluso Cima. La mappa catastale del 1723 attesta che sul sito dell'attuale casa padronale della cascina, un alto fabbricato a C, esisteva una chiesa con convento, fondati, secondo le fonti bibliografiche, nel 1485 ed entrati in uso fin dal 1502. Non è possibile stabilire un confronto puntuale tra la struttura antica e l'edificio oggi esistente in quanto le parcelle catastali sono indicate nella mappa del 1723 molto sommariamente. Si può affermare che le murature della chiesa non esistono più (la chiesa doveva essere posta all'incirca a chiusura dell'alto corpo di fabbrica a C , a sud. E' possibile invece che parti risalgano alla funzione conventuale svolta dal 1502 al 1772, benché siano difficilmente databili, per vari motivi: il tipo dell'edificio alto a C che domina il cortile rurale è del tutto inconsueto per le cascine; presenta lungo il braccio centrale un portico a tre arcate sormontato da loggia altrettanto inconsueto; l'intera ala ovest è edificata sopra un basamento ...Nel 1771 il convento dei Padri Servtiti di Turano veniva soppresso e il 10 febbraio 1772 era messo all'asta. All'epoca vi abitavano cinque religiosi (tre sacerdoti e due laici). La chiesa, che era dotata di tre altari, veniva profanata il 13 febbraio con la traslazione della statua della Beata Vergine dei sette dolori (alla quale era intitolata una confratenita) alla chiesa parrocchiale di Turano. Il complesso dovette essere acquistato dai Calderari, perché nel 1833 compare tra le loro proprietà. La mappa catastale del 1867 mostra la conformazione precisa che aveva all'epoca l'ex convento (diventato esclusivamente cascina da circa 70 anni): si trattava di un unico edificio composto dall'attuale corpo alto a C e da ulteriori tre ali a est che formavano con esso una corte chiusa. Di questa seconda parte resta oggi solo l'ala sud, composta da una prima parte a due piani ortogonale all'ala est del corpo a C e da una stalla di medesima altezza, entrambi edifici di carattere chiaramente rurale, probabilmente edificati nel corso della prima metà dell'Ottocento per dotare l'ex convento di rustici necessari alla nuova funzione. E' possibile che anche il portico addossato lungo il fronte est dell'ala est del corpo a C fosse già stato edificato al 1867 (l'ala risulta avere una profondità identica a quella indicata nella successiva mappa catastale del 1897).La mappa catastale del 1897 attesta la costruzione di alcuni corpi di fabbrica separati dagli edifici preesistenti che andarono ad integrare la dotazione di rustici di cui abbisognava la cascina: si riconosce in particolare la grande stalla posta a nord dell'ex edificio conventuale , tuttora esistente. Gli edifici d'abitazione risultano avere assunto la conformazione attuale, con il corpo alto a C e l'ala ad esso perpendicolare annessa a est, più bassa, mentre le altre due ali che formavano una corte chiusa risultano a questa data demolite. Appare però riconoscibile il piccolo forno annesso a sud all'ala ovest del corpo alto a C . La cascina risulta intestata nel 1887 alla Prebenda Parrocchiale di Turano, allora goduta dal parroco Silvestro Tadini, in virtù del Legato Galmozzi. La mappa catastale del 1897 documenta l'ulteriore ampliamento dei rustici della cascina: il corpo di fabbrica sul confine ovest dell'aia (non più esistente) appare prolungato in direzione sud; a sud della stalla (?) edificata entro il 1867 sono indicati due nuovi corpi di fabbrica rettangolari ad essa paralleli, il primo dei quali tuttora esistente. La cascina risulta appartenere ancora nel 1887 a Carlo Premoli del fu Francesco.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Cascina Terenzano Il nome probabilmente ha origini romane (dalla Gens Terentia). i documenti più antichi che riferiscono di questo luogo sono del 1261 quando la sua chiesa ( per avere una chiesa allora doveva essere già un posto antico, grande e importante per i riferimenti di allora) pagò una tassa di nove denari imperiali al notaio Guala delegato Pontificio della Diocesi di Lodi, il 23 marzo 1359 Barnabò Visconti signore di queste terre, donò il luogo all’Ospedale S. Antonio in Milano, unitamente ad altri beni che possedeva nel Lodigiano; nel 1458 con la soppressione di questo Ospedale i beni di Terrenzano passarono all’Ospedale Maggiore di Milano; nel 1619 questi beni passarono in commenda a Monsignor Landriano Vescovo di Vigevano; alla fine del 1700 passò definitivamente a conti Brivio di Milano. Già allora questo era un grande cascinale con annesso Oratorio, dedicato a Maria Vergine degli Angeli,con il campanile romanico
Il nome probabilmente ha origini romane (dalla Gens Terentia). i documenti più antichi che riferiscono di questo luogo sono del 1261 quando la sua chiesa ( per avere una chiesa allora doveva essere già un posto antico, grande e importante per i riferimenti di allora) pagò una tassa di nove denari imperiali al notaio Guala delegato Pontificio della Diocesi di Lodi, il 23 marzo 1359 Barnabò Visconti signore di queste terre, donò il luogo all’Ospedale S. Antonio in Milano, unitamente ad altri beni che possedeva nel Lodigiano; nel 1458 con la soppressione di questo Ospedale i beni di Terrenzano passarono all’Ospedale Maggiore di Milano; nel 1619 questi beni passarono in commenda a Monsignor Landriano Vescovo di Vigevano; alla fine del 1700 passò definitivamente a conti Brivio di Milano. Già allora questo era un grande cascinale con annesso Oratorio, dedicato a Maria Vergine degli Angeli,con il campanile romanico  un mulino con pileria, un’osteria. Alla fine del 1959 il cascinale si spopolò e venne chiusa l’osteria, nei primi anni ottanta venne abbattuto il mulino e il vecchio oratorio non più adibito a funzioni religiose venne murato. Nella parte più antica della struttura si trovano edifici interessanti sotto l’aspetto architettonico dell’edilizia rurale. Lavori di riqualificazione di altri edifici, un tempo decadenti permettono di ammirare, in ordine una delle cascine ritenuta tra quelle monumentali più importanti del lodigiano. Al 1912 deve risalire una ristrutturazione della stalla dei cavalli posta a est dell'attuale ingresso alla cascina, su strada. La stalla reca infatti questa data sul fronte ovest, ma la struttura è senz'altro più vecchia, sia perché riconoscibile fin dalla mappa catastale del 1867, sia perché la presenza del solaio in legno su colonne in granito che spartiscono l'interno in tre corsie indica una data di costruzione senz'altro precedente. Fin dal sec. XIII esisteva una località "Tarenzano" dotata di chiesa autonoma. Nel 1359 i beni di Terenzano, allora appartenenti a Bernabò Visconti, furono donati all'ospedale di S. Antonio di Milano (che traeva nome dall'omonima chiesa). Con l'istituzione dell'Ospedale Maggiore di Milano, i beni dell'ospedale di S. Antonio furono accorpati a quelli del nuovo ente (1458), ma escludendo la possessione di Terenzano. La chiesa di S. Antonio fu invece istituita in commenda e i beni di Terenzano vennero a far parte delle sue rendite: questo avvenne entro la fine del sec. XVI, quando risulta essere commendatario il vescovo di Vigevano Marsilio Landriano. E' possibile che in questi secoli la località Terenzano fosse già dotata di un abitato, probabilmente prossimo alla chiesa, forse sul sito dell'attuale cascina. La mappa catastale del 1723 costituisce il primo documento dell'esistenza certa di una cascina sul sito dell'attuale. L'area occupata dalla cascina era sostanzialmente coincidente con quella dell'attuale corte principale, escludendo cioè la zona dei salariati, posta a est della stalla e del portico. Su questo sito sorgevano diversi corpi di fabbrica: un ampio edificio all'incirca rettangolare a nord, confinante con la strada (il cui andamento in questo punto era del tutto identico a quello dell'attuale strada provinciale); un corpo di fabbrica minore a sud ovest di questo; un edificio rettangolare stretto e lungo a sud; tre piccoli corpi di fabbrica presso il confine est. Sul sito dei corpi di fabbrica settecenteschi sorgono oggi altri fabbricati, per lo più con diversa dimensione e senz'altro successivi al 1723; tra i corpi di fabbrica che costituiscono oggi la cascina ve ne sono tuttavia tre dall'apparenza piuttosto vecchia, che potrebbero datare al 1723 se non prima ...Nel 1802, col rogito del notaio Gio Batta Giudici di Milano in data 2 settembre, il sig. Pietro Antonio Pioltini acquistava i fondi della soppressa abbazia di S. Antonio. Quindi, il 10 settembre, dichiarava le persone come quelle per conto delle quali aveva stipulato l'atto: Gio Batta Meleri, Giuseppe Pezzoli, le ditte Uboldi e Brunati, Bignami e Vassalli, gli eredi Greppi e Litta Modignani Gio Batta, anche come amministratore dell'eredità Sangiuliani. Nell'atto di vendita la cascina è descritta in modo analitico. L'insieme degli edifici e delle corti è molto complesso e non ricostruibile (ci sono riferimenti ad una mappa non conservata), ma alcune parti sembrano riconoscibili. Alla cascina si accedeva tramite una porta grande con spalle e arco, coperta da tetto, che potrebbe avere lasciato una traccia nel grande arco tamponato presente lungo il muro di cinta a nord, tra la stalla dei cavalli e la casa colonica . Ad un certo punto sono descritti un portico a sei campate ...Con rogito 4 luglio 1805 del notaio Stefano Mannoni di Milano, la ditta Uboldi e Brunetti vendeva la sua parte a Giuseppe Pezzoli. Con rogito 17 aprile dello stesso corrente anno e dello stesso notaio, Sangiuliani vendeva la sua parte sempre al Pezzoli. In seguito a questi atti il 18 giugno 1811 tutta la partita di 2173 pertiche e 17 tavole in Terrenzano era intestata a Giacomo Melleri, al cav. Giuseppe Pezzoli d'Albertone del fu Girolamo, a Gio Batta Litta Modignani ed agli eredi Greppi. Il 9 novembre 1818 tutta la partita veniva intestata ai soli cav. Giuseppe Pezzoli d'Albertone del fu Girolamo e Gio Batta Litta Modignani, in seguito ad atto notarile n. 2035 rogato da Benedetto Cacciatori di Milano. Il 27 giugno 1820 la cascina restava intestata al solo Giuseppe Poldi Pezzoli del fu Gaetano in seguito all'atto di acquisto stipulato in data 16 maggio 1820 con rogito del notaio Benedetto Cacciatore del fu Carlo..Il 5 marzo 1832, per atto di donazione inter vivos in data 29/11/1831 del notaio Luigi Negri di Monza, la cascina era intestata a Giacomo Poldi Pezzoli figlio del vivente Giuseppe, ancora minorenne. La mappa catastale del 1897 mostra la cascina con una consistenza (in pianta) quasi identica a quella di trent'anni prima e molto simile all'attuale. L'unica novità di rilievo consiste nella presenza della nuova casa padronale edificata sul sito di un corpo di fabbrica più stretto e lungo preesistente. La casa è posta a ovest del viottolo di ingresso alla corte principale da nord. In pianta appare di dimensione identica all'attuale e l'aspetto dell'edificio è senz'altro compatibile con una datazione al tardo Ottocento. La grande stalla posta a sud dell'aia appare ingrandita (deve essere stato rifatto il portico che gira attorno) e il profilo in pianta è identico a quello dell'attuale stalla delle vacche. La cascina nel 1887 apparteneva al marchese Luigi Alberico Trivulzio di Gian Giacomo.
un mulino con pileria, un’osteria. Alla fine del 1959 il cascinale si spopolò e venne chiusa l’osteria, nei primi anni ottanta venne abbattuto il mulino e il vecchio oratorio non più adibito a funzioni religiose venne murato. Nella parte più antica della struttura si trovano edifici interessanti sotto l’aspetto architettonico dell’edilizia rurale. Lavori di riqualificazione di altri edifici, un tempo decadenti permettono di ammirare, in ordine una delle cascine ritenuta tra quelle monumentali più importanti del lodigiano. Al 1912 deve risalire una ristrutturazione della stalla dei cavalli posta a est dell'attuale ingresso alla cascina, su strada. La stalla reca infatti questa data sul fronte ovest, ma la struttura è senz'altro più vecchia, sia perché riconoscibile fin dalla mappa catastale del 1867, sia perché la presenza del solaio in legno su colonne in granito che spartiscono l'interno in tre corsie indica una data di costruzione senz'altro precedente. Fin dal sec. XIII esisteva una località "Tarenzano" dotata di chiesa autonoma. Nel 1359 i beni di Terenzano, allora appartenenti a Bernabò Visconti, furono donati all'ospedale di S. Antonio di Milano (che traeva nome dall'omonima chiesa). Con l'istituzione dell'Ospedale Maggiore di Milano, i beni dell'ospedale di S. Antonio furono accorpati a quelli del nuovo ente (1458), ma escludendo la possessione di Terenzano. La chiesa di S. Antonio fu invece istituita in commenda e i beni di Terenzano vennero a far parte delle sue rendite: questo avvenne entro la fine del sec. XVI, quando risulta essere commendatario il vescovo di Vigevano Marsilio Landriano. E' possibile che in questi secoli la località Terenzano fosse già dotata di un abitato, probabilmente prossimo alla chiesa, forse sul sito dell'attuale cascina. La mappa catastale del 1723 costituisce il primo documento dell'esistenza certa di una cascina sul sito dell'attuale. L'area occupata dalla cascina era sostanzialmente coincidente con quella dell'attuale corte principale, escludendo cioè la zona dei salariati, posta a est della stalla e del portico. Su questo sito sorgevano diversi corpi di fabbrica: un ampio edificio all'incirca rettangolare a nord, confinante con la strada (il cui andamento in questo punto era del tutto identico a quello dell'attuale strada provinciale); un corpo di fabbrica minore a sud ovest di questo; un edificio rettangolare stretto e lungo a sud; tre piccoli corpi di fabbrica presso il confine est. Sul sito dei corpi di fabbrica settecenteschi sorgono oggi altri fabbricati, per lo più con diversa dimensione e senz'altro successivi al 1723; tra i corpi di fabbrica che costituiscono oggi la cascina ve ne sono tuttavia tre dall'apparenza piuttosto vecchia, che potrebbero datare al 1723 se non prima ...Nel 1802, col rogito del notaio Gio Batta Giudici di Milano in data 2 settembre, il sig. Pietro Antonio Pioltini acquistava i fondi della soppressa abbazia di S. Antonio. Quindi, il 10 settembre, dichiarava le persone come quelle per conto delle quali aveva stipulato l'atto: Gio Batta Meleri, Giuseppe Pezzoli, le ditte Uboldi e Brunati, Bignami e Vassalli, gli eredi Greppi e Litta Modignani Gio Batta, anche come amministratore dell'eredità Sangiuliani. Nell'atto di vendita la cascina è descritta in modo analitico. L'insieme degli edifici e delle corti è molto complesso e non ricostruibile (ci sono riferimenti ad una mappa non conservata), ma alcune parti sembrano riconoscibili. Alla cascina si accedeva tramite una porta grande con spalle e arco, coperta da tetto, che potrebbe avere lasciato una traccia nel grande arco tamponato presente lungo il muro di cinta a nord, tra la stalla dei cavalli e la casa colonica . Ad un certo punto sono descritti un portico a sei campate ...Con rogito 4 luglio 1805 del notaio Stefano Mannoni di Milano, la ditta Uboldi e Brunetti vendeva la sua parte a Giuseppe Pezzoli. Con rogito 17 aprile dello stesso corrente anno e dello stesso notaio, Sangiuliani vendeva la sua parte sempre al Pezzoli. In seguito a questi atti il 18 giugno 1811 tutta la partita di 2173 pertiche e 17 tavole in Terrenzano era intestata a Giacomo Melleri, al cav. Giuseppe Pezzoli d'Albertone del fu Girolamo, a Gio Batta Litta Modignani ed agli eredi Greppi. Il 9 novembre 1818 tutta la partita veniva intestata ai soli cav. Giuseppe Pezzoli d'Albertone del fu Girolamo e Gio Batta Litta Modignani, in seguito ad atto notarile n. 2035 rogato da Benedetto Cacciatori di Milano. Il 27 giugno 1820 la cascina restava intestata al solo Giuseppe Poldi Pezzoli del fu Gaetano in seguito all'atto di acquisto stipulato in data 16 maggio 1820 con rogito del notaio Benedetto Cacciatore del fu Carlo..Il 5 marzo 1832, per atto di donazione inter vivos in data 29/11/1831 del notaio Luigi Negri di Monza, la cascina era intestata a Giacomo Poldi Pezzoli figlio del vivente Giuseppe, ancora minorenne. La mappa catastale del 1897 mostra la cascina con una consistenza (in pianta) quasi identica a quella di trent'anni prima e molto simile all'attuale. L'unica novità di rilievo consiste nella presenza della nuova casa padronale edificata sul sito di un corpo di fabbrica più stretto e lungo preesistente. La casa è posta a ovest del viottolo di ingresso alla corte principale da nord. In pianta appare di dimensione identica all'attuale e l'aspetto dell'edificio è senz'altro compatibile con una datazione al tardo Ottocento. La grande stalla posta a sud dell'aia appare ingrandita (deve essere stato rifatto il portico che gira attorno) e il profilo in pianta è identico a quello dell'attuale stalla delle vacche. La cascina nel 1887 apparteneva al marchese Luigi Alberico Trivulzio di Gian Giacomo.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
La Zerbaglia Il primo documento dell'esistenza della cascina è molto tardo: sono dopo il 1889 infatti il territorio della Zerbaglia viene separato dal Cremasco, cui da almeno un secolo era già disgiunto dal corso dell'Adda, e viene annesso al Lodigiano, nello specifico al comune di Turano. Poiché per il Cremasco, a differenza del Cremonese, mancano mappe catastali fino a quella del Nuovo Catasto terreni del 1905 (il catasto lombrado veneto si limita ai registri delle partite) il primo documento cartografico è costituito di fatto dalla mappa dell'Istituto Geografico Militare rilevata nel 1889. A quest'epoca la cascina consta solo di un grande corpo di fabbrica a L, con le due ali, di pari dimensioni, il cui vertice guarda a sud ovest. La cascina attuale si presenta invece a corte chiusa, formata da due corpi a L, con interruzione dei corpi di fabbrica a sud ovest e a nord est. Fermi restando il sito e l'orientamento dei corpi di fabbrica, la parte più storica verrebbe dunque a coincidere con ...Nella successiva mappa redatta dall'Istituto Geografico Militare, datata al 1921-1935, la cascina presenta lo schema insediativo attuale: due corpi a L che delimitano una corte chiusa quadrangolare, con ingressi da nord e da sud ovest. La cascina dovrebbe dunque datare prevalentemente alla fine dell'Ottocento o al primo Novecento. Questo datazione può essere compatibile con l'aspetto neomedievale di alcuni corpi di fabbrica, in particolare della vera e propria casa padronale. E' possibile dunque che l'ampliamento della struttura sia avvenuto in coincidenza con la sua destinazione a residenza di villeggiatura e a punto di riferimento per battute di caccia, senza prescindere tuttavia da un'attività di tipo agrario, come denuncia la presenza di stalle e di case coloniche. Nel 1945 la cascina apparteneva al Commendator Granelli.Azienda agricolo-faunistica posta lungo il corso dell’Adda e comprendente anche una parte di fiume nonchè le lanche del vecchio corso. Si estende anche nel vicino comune di Credera con Rubbiano. Comprende Villa Zerbaglia e la Cascina degli Uomini e al di là dell’Adda Cascina Ramelli, Cascina Bosco, Cascina Budrio, Cascina Malpensata. Già di proprietà dei conti Granelli e poi passata ad Antonio Mentasti, ha smesso di funzionare come riserva di caccia alla fine degli anni settanta, è diventata un ambiente protetto a tutela della fauna locale. Praticamente una grande riserva naturalistica privata. Conserva importanti porzioni di bosco ripariale con una grande biodiversità di specie vegetali. Molte sono le specie animali che trovano rifugio nel suo interno, tra queste quasi tutte le specie di avifauna della bassa pianura irrigua; alcune aree marginali sono adibite a coltivazioni agricole.
Il primo documento dell'esistenza della cascina è molto tardo: sono dopo il 1889 infatti il territorio della Zerbaglia viene separato dal Cremasco, cui da almeno un secolo era già disgiunto dal corso dell'Adda, e viene annesso al Lodigiano, nello specifico al comune di Turano. Poiché per il Cremasco, a differenza del Cremonese, mancano mappe catastali fino a quella del Nuovo Catasto terreni del 1905 (il catasto lombrado veneto si limita ai registri delle partite) il primo documento cartografico è costituito di fatto dalla mappa dell'Istituto Geografico Militare rilevata nel 1889. A quest'epoca la cascina consta solo di un grande corpo di fabbrica a L, con le due ali, di pari dimensioni, il cui vertice guarda a sud ovest. La cascina attuale si presenta invece a corte chiusa, formata da due corpi a L, con interruzione dei corpi di fabbrica a sud ovest e a nord est. Fermi restando il sito e l'orientamento dei corpi di fabbrica, la parte più storica verrebbe dunque a coincidere con ...Nella successiva mappa redatta dall'Istituto Geografico Militare, datata al 1921-1935, la cascina presenta lo schema insediativo attuale: due corpi a L che delimitano una corte chiusa quadrangolare, con ingressi da nord e da sud ovest. La cascina dovrebbe dunque datare prevalentemente alla fine dell'Ottocento o al primo Novecento. Questo datazione può essere compatibile con l'aspetto neomedievale di alcuni corpi di fabbrica, in particolare della vera e propria casa padronale. E' possibile dunque che l'ampliamento della struttura sia avvenuto in coincidenza con la sua destinazione a residenza di villeggiatura e a punto di riferimento per battute di caccia, senza prescindere tuttavia da un'attività di tipo agrario, come denuncia la presenza di stalle e di case coloniche. Nel 1945 la cascina apparteneva al Commendator Granelli.Azienda agricolo-faunistica posta lungo il corso dell’Adda e comprendente anche una parte di fiume nonchè le lanche del vecchio corso. Si estende anche nel vicino comune di Credera con Rubbiano. Comprende Villa Zerbaglia e la Cascina degli Uomini e al di là dell’Adda Cascina Ramelli, Cascina Bosco, Cascina Budrio, Cascina Malpensata. Già di proprietà dei conti Granelli e poi passata ad Antonio Mentasti, ha smesso di funzionare come riserva di caccia alla fine degli anni settanta, è diventata un ambiente protetto a tutela della fauna locale. Praticamente una grande riserva naturalistica privata. Conserva importanti porzioni di bosco ripariale con una grande biodiversità di specie vegetali. Molte sono le specie animali che trovano rifugio nel suo interno, tra queste quasi tutte le specie di avifauna della bassa pianura irrigua; alcune aree marginali sono adibite a coltivazioni agricole.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Cascina Bordigherio Con un atto datato 19 maggio 1711 contenuto nell'Archivio del Monastero di S. Chiara Vecchia di Lodi (ora presso l'Archivio di Stato di Milano) e rogato dal notaio Ludovico Berinzago del fu Antonio di Lodi, veniva data in affitto da parte delle monache la "possessione detta li Bordeghè in Cavenago". Si cita il precedente contratto d'affitto stipulato nel 1702. I beni in oggetto sono "prediis et bona appellata il Bordeghé (..) consistentis in diversiis petiis terrarum cum suis edifitiis" (possedimenti e beni chiamati il Bordeghè [...] consistenti in diversi appezzamenti di terra con i relativi edifici). Dunque almeno dal 1702 esisteva una possessione Bordighiero sulla quale erano poste delle costruzioni. Non c'è motivo per pensare che la cascina possa avere da allora mutato posizione, Il fatto che il punto di riferimento geografico sia Cavenago dipende dall'effettiva prossimità di questo centro alla cascina, (assai più di Turano, che peraltro era allora un comune molto più piccolo …
Con un atto datato 19 maggio 1711 contenuto nell'Archivio del Monastero di S. Chiara Vecchia di Lodi (ora presso l'Archivio di Stato di Milano) e rogato dal notaio Ludovico Berinzago del fu Antonio di Lodi, veniva data in affitto da parte delle monache la "possessione detta li Bordeghè in Cavenago". Si cita il precedente contratto d'affitto stipulato nel 1702. I beni in oggetto sono "prediis et bona appellata il Bordeghé (..) consistentis in diversiis petiis terrarum cum suis edifitiis" (possedimenti e beni chiamati il Bordeghè [...] consistenti in diversi appezzamenti di terra con i relativi edifici). Dunque almeno dal 1702 esisteva una possessione Bordighiero sulla quale erano poste delle costruzioni. Non c'è motivo per pensare che la cascina possa avere da allora mutato posizione, Il fatto che il punto di riferimento geografico sia Cavenago dipende dall'effettiva prossimità di questo centro alla cascina, (assai più di Turano, che peraltro era allora un comune molto più piccolo …
Nella mappa catastale del 1723 relativa al comune di Cassina delle Donne (allora autonomo da Turano) è indicata chiaramente la cascina Bordighiero, identificata sulla mappa stessa con la didascalia "Cassina Nuova". Nei registri catastali del 1732 il complesso viene definito "casa e corte da massaro 1" e gli sono assegnati un'ampiezza di 3 pertiche e 3 tavole e un valore di 28 scudi, 1 lira e 7 ottavi. Proprietario è il monastero delle Clarisse di S. Chiara Vecchia di Lodi. La cascina appare composta da due corpi di fabbrica rettangolari disposti rispettivamente sui lati nord ed est di uno spazio rettangolare (la corte citata nei registri), e privi di diretta connessione se non tramite un angolo (lo spigolo sud est del primo coincide con il nord ovest del secondo). Lo spazio cortilizio coincide con l'attuale aia posta immediatamente a sud della stalla con a ovest due edifici. La casa in particolare occupa lo stesso sito di uno degli edifici ...Nell'Archivio del Monastro di S. Chiara Vecchia è conservata una "Descrizione e consegna delle case da fittabile e da piggionante et ogni altro fabbricato e comodo e degli edifici si privativi che comuni annessi alla possessione Cassina nuova detta il Bordeghé posta nel territorio di Cavenago" stesa in data 4-5-6 agosto 1777 dall'ing. Antonio Merlini di Lodi, per rendere conto dei miglioramenti eseguiti nel 1776. La cascina comprendeva: un piccolo portico su due pilastri;una casa ad uso del fittabile (comprendente cantina seminterrata con stanza superiore adibita a granaio, una sala e una cucina con stanze superiori) che doveva sorgere sul lato nord del cortile e aveva un portico annesso verso corte (coincidente forse con la parte sud della casa; una stalla dei buoi e delle vacche e una stalla dei cavalli adiacenti alla casa (poste probabilmente all'incirca sul sito della stalla attuale); due ulteriori campate di casa a due piani; un lungo portico su sei pilastri …
All'inizio del XIX secolo il monastero di S. Chiara vecchia di Lodi veniva soppresso. Nel 1804 la cascina, nel frattempo diventata parte del comune di Robecco (cui era stato annesso quello di Cassina delle Donne) veniva intestata a Giovanni Adamo Kramer del fu Giovanni, l'ultimo livellario del soppresso monastero, che aveva acquistato all'asta il bene, come da rogito in data 27/10/1804 del notaio Alessandro Bellavita di Lodi. Nel 1815 la cascina veniva intestata a Carlo Andrea, Francesco, Ferdinando ed Antonio Kramer, figli del fu Carlo Adamo e alle sorelle Maria Carolina Luigia ed Amalia, a causa della morte del padre il avvenuta il 22 aprile 1815 e in conformità al testamento dello stesso (13/6/1814 consegnato al notaio Giorgio Sacchi di Milano). Il successivo otto luglio il notaio Francesco Maderna di Milano rogava le rinunce delle sorelle al bene in favore dei fratelli. Il 13 settembre 1844 la cascina veniva intestata ai soli Francesco, Ferdinando ed Antonio Kramer figli del fu Gio Adamo per rinuncia da parte di Carlo Andrea Kramer in favore dei suoi fratelli.Il 5 settembre 1854 la cascina veniva intestata solo ai due fratelli Francesco e Ferdinando Kramer del fu Gio Adamo.Il 24 aprile 1862 la cascina restava intestata a solo uno dei fratelli Kramer figli del fu Gio Adamo Francesco In seguito alla morte di Francesco Kramer, avvenuta in data 1/8/1866 e in conformità al suo testamento olografo 3/3/1866 (atto di apertura 4/8/1866 n. 4535 del notaio Pharisen di Milano), il primo novembre 1866 la cascina veniva assegnata all'ing. Edoardo Kramer del fu Carlo Andrea, nipote di Francesco La mappa catastale del 1867 permette di valutare quali parti dell'attuale cascina fossero state a quella data edificate (a meno chiaramente di successive ristrutturazioni). Sul lato est dello spazio a cortile si identifica un lungo corpo di fabbrica rettangolare, alle spalle del quale correva la roggia Tibera. Questo corpo corrisponde all'attuale casa (priva probabilmente del piccolo portichetto e del vano ad esso contiguo oggi addossati ad essa a est), e all'adiacente portico Sul lato nord dell'aia, in angolo con il primo corpo (particolarità conservatasi dal 1722 fino ad oggi) è un secondo edificio di forma complessa. Sembra plausibile che la parte più a est di questo, distinguibile per lo stretto corpo di fabbrica che si prolunga verso nord, corrisponda alla casa d'abitazione tuttora esistente; è probabile inoltre che già allora le case fossero raccordate tramite il lungo portico che costituisce il fronte sud della stalla ...La mappa catastale del 1897 mostra la cascina con un impianto quasi identico all'attuale. Rispetto alla mappa precedente, la stalla risulta ampliata con un ulteriore corpo che si protende verso nord, presentando dunque il singolare impianto a T che permane a tutt'oggi. Allo stato attuale la stalla risulta solo arricchita di un piccolo portico contro parte del fronte ovest; inoltre il portico nord, nel 1897 ancora limitato allo snodo tra la casa e la stalla, si estende oggi per tutto il fronte che sta tra la casa e l'ala nord della stalla stessa. Risulta infine edificato anche il piccolo edificio isolato ad un solo piano con portichetto (quasi sicuramente un forno) posto immediatamente a est della strada di accesso alla cascina, di fronte alla casa . Nel 1887 la cascina risulta appartenere all'Opera Pia Kramer amministrata da Amanzio Tettamanzi.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Cascina Vittoria La prima notizia che si è reperita sull'esistenza della cascina Vittoria data al 1833. Nella mappa catastale del 1723 infatti la cascina non si trova rappresentata. Sul sito che occuperà successivamente è un terreno classificato "zerbo" (gerbido), appartenente al marchese Bartolomeo Calderara. Dopo questa data il terreno resta in eredità a Vittoria Calderari Peluso, vedova del marchese, e quindi, nel 1828, alle sorelle della stessa, Teresa Peluso Vassalli e Giuseppa Peluso Cima, e alle nipoti Vittoria Peluso Crivelli e Benedetta Peluso Martignoni. Finalmente nel 1833, quando fu steso un atto di divisione con cui le sorelle Peluso superstiti si spartirono i beni (atto, rogato il 14 maggio dal notaio Giuseppe Arpegiani di Milano) troviamo compreso anche il "caseggiato da fittabile con corte, ortaglia, orti de' pigionanti e regressi costituenti il Cassinale della Cassina Vittoria". Nell'atto, con cui si assegnava la possessione alla marchesa Teresa Peluso maritata Vassalli ...La mappa catastale del 1867 riporta una prima rappresentazione della cascina.
La prima notizia che si è reperita sull'esistenza della cascina Vittoria data al 1833. Nella mappa catastale del 1723 infatti la cascina non si trova rappresentata. Sul sito che occuperà successivamente è un terreno classificato "zerbo" (gerbido), appartenente al marchese Bartolomeo Calderara. Dopo questa data il terreno resta in eredità a Vittoria Calderari Peluso, vedova del marchese, e quindi, nel 1828, alle sorelle della stessa, Teresa Peluso Vassalli e Giuseppa Peluso Cima, e alle nipoti Vittoria Peluso Crivelli e Benedetta Peluso Martignoni. Finalmente nel 1833, quando fu steso un atto di divisione con cui le sorelle Peluso superstiti si spartirono i beni (atto, rogato il 14 maggio dal notaio Giuseppe Arpegiani di Milano) troviamo compreso anche il "caseggiato da fittabile con corte, ortaglia, orti de' pigionanti e regressi costituenti il Cassinale della Cassina Vittoria". Nell'atto, con cui si assegnava la possessione alla marchesa Teresa Peluso maritata Vassalli ...La mappa catastale del 1867 riporta una prima rappresentazione della cascina.
Attualmente la cascina si presenta ulteriormente sviluppata nella zona a sud dell'originaria corte. Tra gli edifici presenti in quest'area presentano una tecnica costruttiva e materiali ancora tradizionali la stalla e il rustico. A nord, accanto alla casa padronale è stato edificato un piccolo corpo di servizio e il fronte nord della corte è stato prolungato con un fabbricato adibito a rimesse. I fabbricati citati devono essere stati edificati non molto tempo dopo l'ultima rilevazione catastale, considerando le tecniche costruttive tradizionali impiegate. Allo stesso periodo potrebbe risalire il trasferimento dell'ingresso alla corte a ovest (ma potrebbe anche essere recente, in rapporto alla necessità a far entrare mezzi pesanti nella corte).
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Cascina Mirabello Nel 1833 fu steso un atto di divisione, con cui le sorelle Peluso superstiti si spartirono i beni. Con l'atto, rogato il 14maggio dal notaio Giuseppe Arpegiani di Milano, la cascina fu assegnata alla marchesa Teresa Peluso maritata Vassalli. Il 26 ottobre 1840, in seguito alla morte di Teresa Peluso Vassalli avvenuta il giorno 8 agosto, la cascina veniva intestata all'eredità giacente di Peluso, amministrata da don Carlo Vassalli, e ad Elisa Gesnelle maritata Duclos e Gio Gesnelle; quindi, il 26 maggio 1841, a Peluso Francesco e Vittoria per metà e Elisa Gesnelle per l'altro metà. La mappa catastale del 1723 mostra che a quella data era già presente una cascina sul sito dell'attuale; il complesso occupava un lotto trapezoidale che coincide sostanzialmente con l'attuale sito della cascina, posto nell'angolo interno formato dalla roggia Bertonica appena a sud dell'abitato di Turano. La cascina, apparteneva al marchese Antonio Calderara fu Bartolomeo, misurava 6 pertiche e 12 tavole ed era stimata valere 52 scudi. Il 9 agosto 1828 la cascina, rimasta di proprietà di Vittoria Peluso vedova Calderara, veniva assegnata per morte di quest'ultima alle sue sorelle Teresa Peluso Vassalli e Giuseppa Peluso Cima e alle nipoti Vittoria Peluso Crivelli e Benedetta Peluso Martignoni. Il 5 maggio 1846 veniva stipulato tra gli eredi di Teresa Peluso Vassalli un atto di divisione. Il documento, redatto dal notaio Giuseppe Velini di Milano, contiene una descrizione analitica della cascina. Si individuano i principali corpi di fabbrica di cui era composta: un portico a undici campate che includeva l'andito di ingresso (forse uno dei due portoni ad arco tuttora esistenti nel portico a est della corte), una rimessa, le stalle dei buoi e dei cavalli con sopra un fienile in tre campate e la stalla delle vacche; una casa d'abitazione a due piani con sottotetto adibito a granaio (che potrebbe corrispondere alla casa ), tre ulteriori portici. Vi erano inoltre un "barco delle vacche" a 10 campate, diversi porcili, due pollai, il pozzo e un forno: nel complesso più edifici di quanti non ne siano rimasti oggi, tanto che la corte era chiusa "per la massima parte da caseggiato".
Nel 1833 fu steso un atto di divisione, con cui le sorelle Peluso superstiti si spartirono i beni. Con l'atto, rogato il 14maggio dal notaio Giuseppe Arpegiani di Milano, la cascina fu assegnata alla marchesa Teresa Peluso maritata Vassalli. Il 26 ottobre 1840, in seguito alla morte di Teresa Peluso Vassalli avvenuta il giorno 8 agosto, la cascina veniva intestata all'eredità giacente di Peluso, amministrata da don Carlo Vassalli, e ad Elisa Gesnelle maritata Duclos e Gio Gesnelle; quindi, il 26 maggio 1841, a Peluso Francesco e Vittoria per metà e Elisa Gesnelle per l'altro metà. La mappa catastale del 1723 mostra che a quella data era già presente una cascina sul sito dell'attuale; il complesso occupava un lotto trapezoidale che coincide sostanzialmente con l'attuale sito della cascina, posto nell'angolo interno formato dalla roggia Bertonica appena a sud dell'abitato di Turano. La cascina, apparteneva al marchese Antonio Calderara fu Bartolomeo, misurava 6 pertiche e 12 tavole ed era stimata valere 52 scudi. Il 9 agosto 1828 la cascina, rimasta di proprietà di Vittoria Peluso vedova Calderara, veniva assegnata per morte di quest'ultima alle sue sorelle Teresa Peluso Vassalli e Giuseppa Peluso Cima e alle nipoti Vittoria Peluso Crivelli e Benedetta Peluso Martignoni. Il 5 maggio 1846 veniva stipulato tra gli eredi di Teresa Peluso Vassalli un atto di divisione. Il documento, redatto dal notaio Giuseppe Velini di Milano, contiene una descrizione analitica della cascina. Si individuano i principali corpi di fabbrica di cui era composta: un portico a undici campate che includeva l'andito di ingresso (forse uno dei due portoni ad arco tuttora esistenti nel portico a est della corte), una rimessa, le stalle dei buoi e dei cavalli con sopra un fienile in tre campate e la stalla delle vacche; una casa d'abitazione a due piani con sottotetto adibito a granaio (che potrebbe corrispondere alla casa ), tre ulteriori portici. Vi erano inoltre un "barco delle vacche" a 10 campate, diversi porcili, due pollai, il pozzo e un forno: nel complesso più edifici di quanti non ne siano rimasti oggi, tanto che la corte era chiusa "per la massima parte da caseggiato".
La cascina era assegnata alla nobile Elisa Gesnelle maritata Duclos de Piazzoni ...Il 4 gennaio 1863 la cascina veniva intestata a Bignami Emilio fu Giuseppe per acquisto, come da atto in data 8 novembre 1862 rogato da Achille Bignami notaio di Lodi (n. 1230 del suo repertorio).La mappa catastale del 1867 mostra chiaramente la consistenza degli edifici allora presenti intorno alla corte (attestata al 1723). Sulla facciata ovest della stalla dei cavalli con fienile superiore, che occupa tre campate del portico a est della corte, è iscritta la data 1888. E' probabile che a questa data non sia stato ricostruito l'intero portico ma che siano state tamponate queste campate per ottenere il ricovero per gli animali. Se invece la data si riferisce ad una ricostruzione dell'intero portico, questa fu effettuata riconfermando l'ingombro del corpo preesistente. La mappa catastale del 1897 mostra una cascina quasi identica a quella di trent'anni prima, se si eccettua la presenza di un nuovo corpo di fabbrica a sud est della corte, contiguo al portico già esistente ma più profondo (e realizzato almeno in parte su preesistenze). In esso è riconoscibile la grande stalla tuttora esistente al termine dell'ala est della cascina. Nel 1887 il proprietario era ancora Emilio Bignami del fu Giuseppe.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Cascina Novella La mappa catastale del 1722 mostra che a quella data era già presente una cascina sul sito dell'attuale. La cascina occupava un lotto rettangolare che coincide sostanzialmente con l'attuale sito: i confini nord e sud sono immutati mentre a est e a ovest l'attuale cascina a corte occupa un di terreno leggermente più ampio. La mappa rappresenta la cascina come un singolo corpo di fabbrica a L posto quasi al centro del lotto; la giacitura di questo edificio non trova riscontri nell'attuale complesso, sviluppato sul perimetro dell'appezzamento. Nel 1732 la cascina, contrassegnata con il n. di mappa 74, apparteneva al marchese Antonio Calderara del fu Bartolomeo, misurava 3 pertiche e 9 tavole ed era valutata 28 scudi, 4 lire e 1 ottavo. Il 9 agosto 1828 la cascina, rimasta di proprietà di Vittoria Peluso vedova Calderara, veniva assegnata per morte di quest'ultima alle sue sorelle Teresa Peluso Vassalli e Giuseppa Peluso Cima e alle nipoti Vittoria Peluso Crivelli e Benedetta Peluso Martignoni. Nel 1833 fu steso un atto di divisione, con cui le sorelle Peluso superstiti si spartirono i beni. Con l'atto, rogato il 14 maggio dal notaio Giuseppe Arpegiani di Milano, la cascina fu assegnata alla marchesa Teresa Peluso maritata Vassalli . Il 26 ottobre 1840, in seguito alla morte di Teresa Peluso Vassalli avvenuta il giorno 8 agosto, la cascina veniva intestata all'eredità giacente di Peluso, amministrata da don Carlo Vassalli, e ad Elisa Gesnelle maritata Duclos e Gio Gesnelle; quindi, il 26 maggio 1841, a Peluso Francesco e Vittoria per metà e Elisa Gesnelle per l'altro metà. Il 5 maggio 1846 veniva stipulato tra gli eredi di Teresa Peluso Vassalli un atto di divisione. Il documento, redatto dal notaio Giuseppe Velini di Milano, contiene una descrizione analitica della cascina. Si individuano diversi corpi di fabbrica tuttora esistenti: a sud era la porta d'ingresso chiusa da imposte, senz'altro sul sito dell'attuale con grande arcone a finte bugne (forse già esistente). Viene quindi descritto un portico a sei campate da cui si entrava in una rimessa e che distribuiva alla casa del fittabile, a due piani: la descrizione coincide perfettamente con l'attuale casa padronale, che sul lato est ha un portico in sei campate, dal quale a sud tramite una grande apertura ad arco munita di vecchi battenti di legno si accede alla rimessa. All'angolo nord ovest erano sei pollai (forse sul sito del locale più a sud della porcilaia). Seguiva sul lato nord un portico a 10 campate che serviva una casa colonica di quattro stanze, ciascuna con locale superiore La mappa catastale del 1867 mostra una cascina di impianto molto simile all'attuale: è formata da tre corpi di fabbrica disposti a C che sorgono sui fronti sud ovest e nord dell'aia (il centrale adibito a casa principale) con un piccolo ambiente sullo snodo a nord ovest. Rispetto allo stato attuale il fronte sud è più esteso ad est e non è possibile sapere se la parte ovest includesse già gli edifici attuali (una casa colonica, un portico a due campate e , al di là dell'androne, un locale ad un solo piano). Non esistevano ancora il portico a est e la porcilaia. Nella mappa catastale del 1897 la cascina appare quasi immutata. E' evidente solo l'addizione di un nuovo corpo di fabbrica a est, coincidente con il portico che si trova oggi in questo sito . Il fronte sud presenta un corpo di fabbrica meno sviluppato a est rispetto a trent'anni prima, di lunghezza grosso modo coincidente con l'attuale. E' possibile che in occasione di questa trasformazione sia stata definita anche la sequenza degli edifici che oggi compongono questo fronte. Nel complesso questi corpi di fabbrica (case coloniche, portico, androne di ingresso, locale) paiono senz'altro compatibili con una datazione all'Ottocento. Nel 1887 la cascina risulta intestata a Caterina Bianchi del fu Luigi, vedova Dellanoce. La porcilaia annessa a nord alla casa padronale (deve essere stata edificata dopo il 1897 (ad eccezione forse del primo ambiente a sud, che oggi funge da disimpegno, di profondità differente, che probabilmente preesisteva). Data la realizzazione con tecniche costruttive tradizionali, deve datare alla prima parte del sec. XX.
La mappa catastale del 1722 mostra che a quella data era già presente una cascina sul sito dell'attuale. La cascina occupava un lotto rettangolare che coincide sostanzialmente con l'attuale sito: i confini nord e sud sono immutati mentre a est e a ovest l'attuale cascina a corte occupa un di terreno leggermente più ampio. La mappa rappresenta la cascina come un singolo corpo di fabbrica a L posto quasi al centro del lotto; la giacitura di questo edificio non trova riscontri nell'attuale complesso, sviluppato sul perimetro dell'appezzamento. Nel 1732 la cascina, contrassegnata con il n. di mappa 74, apparteneva al marchese Antonio Calderara del fu Bartolomeo, misurava 3 pertiche e 9 tavole ed era valutata 28 scudi, 4 lire e 1 ottavo. Il 9 agosto 1828 la cascina, rimasta di proprietà di Vittoria Peluso vedova Calderara, veniva assegnata per morte di quest'ultima alle sue sorelle Teresa Peluso Vassalli e Giuseppa Peluso Cima e alle nipoti Vittoria Peluso Crivelli e Benedetta Peluso Martignoni. Nel 1833 fu steso un atto di divisione, con cui le sorelle Peluso superstiti si spartirono i beni. Con l'atto, rogato il 14 maggio dal notaio Giuseppe Arpegiani di Milano, la cascina fu assegnata alla marchesa Teresa Peluso maritata Vassalli . Il 26 ottobre 1840, in seguito alla morte di Teresa Peluso Vassalli avvenuta il giorno 8 agosto, la cascina veniva intestata all'eredità giacente di Peluso, amministrata da don Carlo Vassalli, e ad Elisa Gesnelle maritata Duclos e Gio Gesnelle; quindi, il 26 maggio 1841, a Peluso Francesco e Vittoria per metà e Elisa Gesnelle per l'altro metà. Il 5 maggio 1846 veniva stipulato tra gli eredi di Teresa Peluso Vassalli un atto di divisione. Il documento, redatto dal notaio Giuseppe Velini di Milano, contiene una descrizione analitica della cascina. Si individuano diversi corpi di fabbrica tuttora esistenti: a sud era la porta d'ingresso chiusa da imposte, senz'altro sul sito dell'attuale con grande arcone a finte bugne (forse già esistente). Viene quindi descritto un portico a sei campate da cui si entrava in una rimessa e che distribuiva alla casa del fittabile, a due piani: la descrizione coincide perfettamente con l'attuale casa padronale, che sul lato est ha un portico in sei campate, dal quale a sud tramite una grande apertura ad arco munita di vecchi battenti di legno si accede alla rimessa. All'angolo nord ovest erano sei pollai (forse sul sito del locale più a sud della porcilaia). Seguiva sul lato nord un portico a 10 campate che serviva una casa colonica di quattro stanze, ciascuna con locale superiore La mappa catastale del 1867 mostra una cascina di impianto molto simile all'attuale: è formata da tre corpi di fabbrica disposti a C che sorgono sui fronti sud ovest e nord dell'aia (il centrale adibito a casa principale) con un piccolo ambiente sullo snodo a nord ovest. Rispetto allo stato attuale il fronte sud è più esteso ad est e non è possibile sapere se la parte ovest includesse già gli edifici attuali (una casa colonica, un portico a due campate e , al di là dell'androne, un locale ad un solo piano). Non esistevano ancora il portico a est e la porcilaia. Nella mappa catastale del 1897 la cascina appare quasi immutata. E' evidente solo l'addizione di un nuovo corpo di fabbrica a est, coincidente con il portico che si trova oggi in questo sito . Il fronte sud presenta un corpo di fabbrica meno sviluppato a est rispetto a trent'anni prima, di lunghezza grosso modo coincidente con l'attuale. E' possibile che in occasione di questa trasformazione sia stata definita anche la sequenza degli edifici che oggi compongono questo fronte. Nel complesso questi corpi di fabbrica (case coloniche, portico, androne di ingresso, locale) paiono senz'altro compatibili con una datazione all'Ottocento. Nel 1887 la cascina risulta intestata a Caterina Bianchi del fu Luigi, vedova Dellanoce. La porcilaia annessa a nord alla casa padronale (deve essere stata edificata dopo il 1897 (ad eccezione forse del primo ambiente a sud, che oggi funge da disimpegno, di profondità differente, che probabilmente preesisteva). Data la realizzazione con tecniche costruttive tradizionali, deve datare alla prima parte del sec. XX.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Cascina Nuova L'otto maggio 1849 la cascina veniva intestata all'ing. Antonio, a don Carlo e a Luigi Premoli, fratelli, figli del fu Francesco, per acquisto come da atto in data 6 marzo 1849 n. 3112 del notaio Giuseppe Velini di Milano. La mappa catastale del 1723 mostra che a quella data era già presente una cascina sul sito dell'attuale; il complesso,denominato nei registri catastali "casa da massaro", come un singolo lotto quasi quadrato, con un orto annesso a ovest e a sud. I confini nord, ovest ed est del lotto coincidono con quelli dell'attuale corte; a sud invece la cascina si presenta oggi un po' più estesa, avendo annessa una striscia di terreno. La cascina apparteneva al marchese Antonio Calderara fu Bartolomeo, misurava 11 pertiche e 19 tavole per un valore di 94 scudi e 2 lire. La mappa non dà indicazione degli edifici costruiti sul lotto. L'aspetto della casa padronale è compatibile con la sua esistenza a questa data (a prescindere dal portico di tre campate addossato a sud). Più anonimi, e quindi di più difficile datazione, appaiono i fabbricati annessi a ovest e a est (stalla) e le lunghissime case coloniche presenti sul fronte est della corte ...
L'otto maggio 1849 la cascina veniva intestata all'ing. Antonio, a don Carlo e a Luigi Premoli, fratelli, figli del fu Francesco, per acquisto come da atto in data 6 marzo 1849 n. 3112 del notaio Giuseppe Velini di Milano. La mappa catastale del 1723 mostra che a quella data era già presente una cascina sul sito dell'attuale; il complesso,denominato nei registri catastali "casa da massaro", come un singolo lotto quasi quadrato, con un orto annesso a ovest e a sud. I confini nord, ovest ed est del lotto coincidono con quelli dell'attuale corte; a sud invece la cascina si presenta oggi un po' più estesa, avendo annessa una striscia di terreno. La cascina apparteneva al marchese Antonio Calderara fu Bartolomeo, misurava 11 pertiche e 19 tavole per un valore di 94 scudi e 2 lire. La mappa non dà indicazione degli edifici costruiti sul lotto. L'aspetto della casa padronale è compatibile con la sua esistenza a questa data (a prescindere dal portico di tre campate addossato a sud). Più anonimi, e quindi di più difficile datazione, appaiono i fabbricati annessi a ovest e a est (stalla) e le lunghissime case coloniche presenti sul fronte est della corte ...
Il 9 agosto 1828 la cascina, rimasta di proprietà di Vittoria Peluso vedova Calderara, veniva assegnata per morte di quest'ultima alle sue sorelle Teresa Peluso Vassalli e Giuseppa Peluso Cima e alle nipoti Vittoria Peluso Crivelli e Benedetta Peluso Martignoni. Nel 1833 fu steso un atto di divisione, con cui le sorelle Peluso superstiti si spartirono i beni. Con l'atto, rogato il 14 maggio dal notaio Giuseppe Arpegiani di Milano, l'edificio, denominato "la cassina Nuova [...] con cassina e case da piggionanti", fu assegnato a Teresa Peluso maritata Vassalli. Il 26 ottobre 1840, in seguito alla morte di Teresa Peluso Vassalli avvenuta il giorno 8 agosto, la cascina veniva intestata all'eredità giacente di Peluso, amministrata da don Carlo Vassalli, e ad Elisa Gesnelle maritata Duclos e Gio Gesnelle; quindi, il 26 maggio 1841, a Peluso Francesco e Vittoria per metà e Elisa Gesnelle per l'altro metà. Il 30 gennaio 1849 la cascina fu intestata ai nobili Francesco Peluso, Benedetta Peluso maritata Martignoni, e Vittoria Pelsuso maritata Crivelli Visconti, fratello e sorelle, in comune, in seguito alla divisione tra gli eredi di Vittoria Calderara fatta dagli ing. Stoppani e Cadoretti il 20/3/1846 e depositata presso il notaio Giuseppe Velini di Milano (atto 5 maggio 1846). Nell'atto la cascina è descritta analiticamente. A nord era l'andito d'ingresso, tuttora esistente nella parte est della casa padronale (oggi non più impiegato per lo spostamento dell'accesso principale e della sede stradale a sud).
Accanto era la casa con portico addossato a 10 campate (forse sul sito della stalla), a tre piani, con cucina, sala e diverse stanze. Sui lati nord est e sud della corte si disponevano ancora un "barco delle vacche" a otto campate con mangiatoia, un portico con sotto porcili, il forno, pollai, la casa dei pigionanti a tre piani, una rimessa, una colombaia, le stalle per i buoi. L'otto maggio 1862 la cascina passava al dr. Carlo Premoli del fu Francesco per divisione, come da atto in data 25 marzo 1862 rogato da Pietro Commizzoli, notaio di Lodi.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Cascina Cassinazza La mappa catastale del 1722 mostra che a questa data esisteva già una grande cascina sul terreno dove sorge l'attuale. La mappa riporta due edifici: uno a nord con forma a L, la cui ala orientata in direzione est ovest coincide sostanzialmente con la successione dei corpi di fabbrica della cascina attuale; uno adiacente al primo a sud, con impianto a C, il cui confine nord è ricalcato dall'ala est della casa.
La mappa catastale del 1722 mostra che a questa data esisteva già una grande cascina sul terreno dove sorge l'attuale. La mappa riporta due edifici: uno a nord con forma a L, la cui ala orientata in direzione est ovest coincide sostanzialmente con la successione dei corpi di fabbrica della cascina attuale; uno adiacente al primo a sud, con impianto a C, il cui confine nord è ricalcato dall'ala est della casa.
Rispetto agli edifici oggi esistenti sono certamente più tardi il piccolo portico, la stalla, la casa con la piccola stalla adiacente e i rustici. Del corpo di fabbrica esistente sul confine nord della cascina è probabilmente di origine settecentesca la casa d'abitazione, con il grande arcone di ingresso. Resta dubbia la datazione, che in ogni caso sorge su preesistenze attestate al 1722. Proprietario della casa, secondo i registri catastali del 1732 è il conte senatore Stefano Gaetano Crivelli del fu Gio Angelo ...Il 28 gennaio 1774, in conformità al testamento steso dal conte Stefano Gaetano Crivelli in data 14 settembre 1764 (notaio Carlo Vincenzo del Majno di Milano), la cascina veniva assegnata al conte don Giuseppe Antonio Gaspare Crivelli, figlio del defunto Stefano Gaetano.
Il 21 maggio 1821 la cascina, che risulta a questa data intestata al conte Ferdinando Crivelli fu Antonio, e a Enrico e Alberto Crivelli, rispettivamente padre e figli, il primo usufruttuario e i secondi eredi del fu conte Ignazio Crivelli, viene intestata al solo conte Ferdinando Crivelli in virtù dell'atto di acquisto rogato in data 18 aprile 1821 dal notaio Cristoforo Caimi del fu Andrea Il 18 maggio 1856 la cascina viene intestata al conte cav. Alberto Crivelli del fu Ferdinando per eredità. Nel 1887 la cascina risulta intestata al conte Giuseppe Crivelli fu Alberto, tutelato dalla madre duchessa Maria Serbelloni
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Mulino Valguercia La mappa catastale del 1722 mostra che a quella data era già presente una mulino sul sito dell'attuale; l'edificio è indicato come un corpo lotto rettangolare e doveva essere senz'altro di dimensioni più ridotte rispetto allo stato attuale. Il corpo è indicato sul sito che successivamente sarà occupato dal mulino vero e proprio, cioè nella parte più a est del complesso attuale. Non è escluso che le parti inferiori delle murature (assai massicce) dell'attuale parte est del fabbricato risalgano anche indietro a queste date. L'edificio, accatastato come "casa per molino di due ruote d'affitto della Valle Guercia", apparteneva nel 1732 al conte Giovan Battista Scotti, misurava 4 tavole ed era valutato 1 scudo, 2 lire e 4 ottavi. Entro il 1840 il mulino passa in eredità a Carlo Scotti del fu Giovanni Battista.
La mappa catastale del 1722 mostra che a quella data era già presente una mulino sul sito dell'attuale; l'edificio è indicato come un corpo lotto rettangolare e doveva essere senz'altro di dimensioni più ridotte rispetto allo stato attuale. Il corpo è indicato sul sito che successivamente sarà occupato dal mulino vero e proprio, cioè nella parte più a est del complesso attuale. Non è escluso che le parti inferiori delle murature (assai massicce) dell'attuale parte est del fabbricato risalgano anche indietro a queste date. L'edificio, accatastato come "casa per molino di due ruote d'affitto della Valle Guercia", apparteneva nel 1732 al conte Giovan Battista Scotti, misurava 4 tavole ed era valutato 1 scudo, 2 lire e 4 ottavi. Entro il 1840 il mulino passa in eredità a Carlo Scotti del fu Giovanni Battista.
Il 18 aprile 1840 il mulino risulta fare parte dell'eredità giacente Scotti, a causa della morte di Carlo Scotti avvenuta in data 5/2/1840. Il 16 marzo 1841 viene quindi intestato al conte Tomaso Scotti duca di S. Pietro, ai conti Gio e Filippo Scotti, alla contessa Giuseppa, a Edoardo di Castelbarco, a Maria Camilla fu Carlo Scotti e a Giuseppe e Camilla Tornielli. Il due settembre 1843 il mulino veniva intestato al conte Tomaso Scotti del fu Carlo in seguito all'atto di divisione tra eredi rogato in data 10/7/1843 da Francesco Sormani, notaio di Milano.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Le Edicole dei SANTi
via Gramsci
via Pecchi
via Garibaldi

Piazza 25 Aprile Cascina Mairaga Via Matteotti Melegnanello

cascina Robecco

Cappella ai Defunti presso chiesa S.Ilario, Melegnanello

particolare interno cappella defunti presso chiesa S.Ilaro Melegnanello
Dipinto all'interno del portico di Cascina Cassinazza corte dei salariati, Melegnanello
Edicola alla Madonna con bambino cascina Bolchignano, Melegnanello

Mosaico sulla facciata della Chiesa a S. Ilario, Melegnanello
******************************************************************************
Il Territorio, le Piste Ciclabili e i percorsi Agrofaunistici
Piste ciclo-pedonali
Dal confine nord-ovest con il comune di Basiasco si snoda una pista asfaltata tra il verde intenso della vegetazione su quello che era il vecchio tracciato della Vecchia Cremonese, che è costeggiata da canali sia a destra che a sinistra fino a giungere al canale Muzza, da qui ci si può inoltrare sia verso il lato destro della Muzza stessa, e il canale Tagliana o Cotta, su una pista non asfaltata e con qualche passaggio un pò precario,
su una pista non asfaltata e con qualche passaggio un pò precario, ci si trova con la Muzza sulla sinistra e la Tagliana/Cotta sulla destra, ma di assoluta bellezza,
ci si trova con la Muzza sulla sinistra e la Tagliana/Cotta sulla destra, ma di assoluta bellezza,


 sia come tranquillità, che come ambiente nel quale si possono incontrare diverse tipologie di volatili e di animali del fiume;
sia come tranquillità, che come ambiente nel quale si possono incontrare diverse tipologie di volatili e di animali del fiume;








 procedendo su questa pista sempre costeggiando la Muzza si arriva oltre Bertonico. Se invece si vuole continuare sulla pista asfaltata, che comunque si sviluppa con salite e discese gradevoli sempre avendo la Muzza sulla destra in un ambiente immerso nel verde dove si incontrano scorci veramente affascinanti, fino a giungere alla Colombina in territorio di Bertonico. Percorso consigliato, anche ai pedoni anche con bambini, però con molta attenzione agli eventuali ciclisti che spesso sfrecciano incautamente.
procedendo su questa pista sempre costeggiando la Muzza si arriva oltre Bertonico. Se invece si vuole continuare sulla pista asfaltata, che comunque si sviluppa con salite e discese gradevoli sempre avendo la Muzza sulla destra in un ambiente immerso nel verde dove si incontrano scorci veramente affascinanti, fino a giungere alla Colombina in territorio di Bertonico. Percorso consigliato, anche ai pedoni anche con bambini, però con molta attenzione agli eventuali ciclisti che spesso sfrecciano incautamente.
Qualche cenno storico sulla Muzza, canale di cui si ha traccia sin dai tempi pre romani quando la Muzza era un ramo naturale dell'Adda che iniziava a Cassano d'Adda e disperdeva le sue acque nella pianura. Il nome del Canale deriva dal nome della famiglia romana Mutia, che nel 90 a. C., si trasferì da Roma, proprietario di quei terreni era un certo Tito Muzio, che per poterli irrigare, fece scavare un canale che pescava le acque da questo ramo naturale dell'Adda vicino a Paullo. Da allora le acque di questo canale vennero chiamate "acquae Mutiae". Con le invasioni barbariche, in pochi decenni queste opere di bonifica faticosamente realizzate vanno in rovina , verso il 1150 d.C nella parte di territorio posto a ovest del fiume Adda venne attuato un progetto di bonifica che rendeva disponibile un esteso territorio fertile e coltivabile rendendo indispensabili le operazioni d'irrigazione. Nel 1218, terminate le guerre presso la città di Lodi, Federico II assegna ai lodigiani il canale, ai quali, viene attribuita la costruzione (dal 1220 al 1230) della parte di canale a valle di Paullo fino a Castiglione d'Adda, dove rientra nel fiume originario. Tale costruzione ha praticamente triplicato la lunghezza del canale originario e corrisponde al percorso attuale che attraverso rogge e canali che da esso dipartono permette di irrigare 67.000 ettari di territorio.
sponde dell’Adda



Il territorio
Ha molti percorsi ciclo-pedonali con tracciati in prevalenza non asfaltati, ad esempio: il tracciato che percorrevano un tempo per recarsi in
pellegrinaggio alla Madonna della Costa a Cavenago,

il percorso che porta alla Madonnina dell’Adda,

il reticolo delle strade interpoderali inoltre garantisce una discreta accessibilità ad aree di interesse agri-faunistico, non ancora del tutto valorizzate
""""""""""""""""""""""""""""
La centrale a turbogas da 800 Mw 
la ciminiera della raffineria ex sarni gulf 
150 m. di altezza, abbattuta nel 2010 vedi video---->www.youtube.com/watch?v=MZXpFgNG_UE
il territorio non è stato immune negli anni da attacchi che hanno cercato di cambiare il suo assetto che è sempre stato prevalentemente agricolo, infatti già negli anni 1970 venne ad insediarsi tra i comuni di Bertonico e Turano Lodigiano una raffineria che creò non pochi problemi al territorio, dopo appena una decina di anni però cessò di funzionare e l’enorme area praticamente restò abbandonata finchè si decise di bonificarla, immediatamente si fecero avanti vari progetti, tra i più contestati, quello di costrure un inceneritore, fortunatamente bocciato, poi quello di costrure una centrale elettrica, anche questo progetto fu fortemente contestato, ma alla fine nel 2008 iniziarono i lavori di costruzione e nel 2010 entrò in funzione .
La voglia di realizzare profitti da parte di privati non si ferma qui, in una area prossima alla centrale (sempre nel comune di Turano Lodigiano) nel 2011 con la scusa di produrre energie alternative ecco un bell'impianto di pannelli solari a terra, con l'utilizzo distrorto del territorio, tra i più produttivi d'Italia, con la perdita di ulteriori spazi agricoli 
""""""""""""""""""""""""""""""""
Il Lago Gerundo e il Drago Tarantasio
Si possono notare ancora oggi nella parte nord di Turano, nella conca che va da Cavenago e scende verso il santuario della Madonna della Costa, la Cascina delle Donne, la Cascina del Monastero di San Lorenzo, la Cascina Braglia, il Palazzo Calderari, la Chiesa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria e Cascina Mairaga quelle che sembrano essere state le sponde del Lago Gerundo, che pare occupasse tutta la zona più bassa del territorio, lago ,che a seguito delle bonifiche e della riduzione della portata dei fiumi Adda, Serio e Sillario lentamente si ridusse, per praticamente scomparire intorno all’anno milletrecento, anche se si sono avute tracce residue fino al 1900 come il lago di Meleti scomparso intorno al 1940.
confini stimati del lago nei periodi di media espansione
La Leggenda
La fantasia popolare narra che un tempo nelle acque del Lago Gerundo vivesse un drago di nome Tarantasio, che avvicinandosi alle rive, faceva strage di uomini e soprattutto di bambini e che ammorbava l'aria circostante con il suo alito asfissiante. Le esalazioni, in effetti, erano dovute alla presenza nel sottosuolo di metano e di idrogeno solforato, un fenomeno misterioso per la popolazione di allora, che pertanto, incolpava esseri sconosciuti e fantasiosi.
Il fantomatico mostro, secondo la leggenda, fu ammazzato da uno sconosciuto eroe che prosciugò anche il lago: pare che fosse Uberto Visconti di Milano che, dopo tale prodezza, adottò come suo stemma l'immagine del biscione.  Alcune fonti popolari attribuiscono il prosciugamento e la bonifica del lago a san Cristoforo, che avrebbe sconfitto il drago, o a Federico Barbarossa. La bonifica del territorio fu in realtà fatta dai monaci delle abbazie vicine. Si ritiene comunemente che in verità le acque scomparvero in seguito a progressive opere di bonifica in atto già da tempo, in particolare il potenziamento del canale della Muzza da parte dei lodigiani, oltre a fattori di drenaggio e assestamenti geologici, con lo scioglimenti dei ghiacciai con la conseguente riduzione della portata dei fiumi Adda, Oglio, Sillario e Serio oltre al livellamento di depositi morenici nei pressi dell'immissione dell'Adda nel Po.
Alcune fonti popolari attribuiscono il prosciugamento e la bonifica del lago a san Cristoforo, che avrebbe sconfitto il drago, o a Federico Barbarossa. La bonifica del territorio fu in realtà fatta dai monaci delle abbazie vicine. Si ritiene comunemente che in verità le acque scomparvero in seguito a progressive opere di bonifica in atto già da tempo, in particolare il potenziamento del canale della Muzza da parte dei lodigiani, oltre a fattori di drenaggio e assestamenti geologici, con lo scioglimenti dei ghiacciai con la conseguente riduzione della portata dei fiumi Adda, Oglio, Sillario e Serio oltre al livellamento di depositi morenici nei pressi dell'immissione dell'Adda nel Po.
Ubicazione
Il lago occupava un ampio tratto di territorio tra Adda e Serio, ma anche, secondo alcuni, Brembo e Oglio. Tale localizzazione comprende quindi le provincie di Bergamo, Lodi e Cremona e Milano.
La costa est del lago, secondo alcuni autori, raggiungeva Fara Olivana e proseguiva, passando ad est di Crema, sino a Grumello Cremonese; continuando poi ad occupare parte delle valli del Chiese e dell'Oglio sin quasi alla sua immissione nel Po. In particolare, si può osservare una vasta zona delimitata da una scarpata che indica l'antico alveo del lago, o meglio la zona più profonda; tale demarcazione è oggi fortemente visibile nei pressi della sponda occidentale dell'Adda, da Cassano a Castiglione. L'ampiezza massima del lago, comprendente le zone paludose, è andata comunque oltre, a causa dell'abbandono delle opere di bonifica durante il medioevo. Al centro del lago si ergeva una lunga e stretta striscia di terra che iniziava presso Caravaggio, raggiungeva Crema e proseguiva sin oltre Castelleone.
Il suolo declina verso il letto attuale dei fiumi alle volte con suggestive concrezioni e/o pendenze, come nel territorio di Truccazzano, sulla strada provinciale 14 "Rivoltana", a Formigara, e a Chieve.
Numerosi sono i comuni che dedicano una via al lago scomparso, mentre nella parte bergamasca del comune di Cassano d'Adda, esiste la località Taranta, probabilmente derivata dalla leggenda del drago.
Realtà storica
Datazioni geologiche permettono di rilevare che già 5000 anni fa la valle dell'Adda era già formata, e si presentava così come è ora. Il fiume ha comunque mostrato ampliamento di meandri e divagazioni del corso in misura maggiore che non l'Oglio, per esempio. La zona era inoltre abitata, essendo stati ritrovati insediamenti gallici (III e II secolo a.C.) e romani, nonché una strada romana da Milano a Cremona, in pieno "lago Gerundo". Per questo diventa più che attendibile l'analisi del prof. Riccardo Caproni dell'università di Bergamo che trovate qui di seguito cliccando su www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=rzy0IAfEM74

.
 quella che viene considerata una costola del Drago Taranto lunga 1,70 metri conservata nella sagrestia della chiesa di San Bassiano a Pizzighettone
quella che viene considerata una costola del Drago Taranto lunga 1,70 metri conservata nella sagrestia della chiesa di San Bassiano a Pizzighettone
Ancora negli anni dopo il 1950 la leggenda del drago ha avuto grande risalto, tanto che, si dice venne preso a spunto per la creazione del logo dell'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) con il famoso cane a sei zampe che sputa fuoco
Storia e cultura di Eni in un marchio di successo
Tutto comincia nel 1952, quando il cane a sei zampe opera dell’artista Luigi Broggini viene premiato ad unconcorso pubblicitario indetto da Eni. Il nuovo simbolo desta da subito curiosità, che si alimenta nel corso degli anni per la ritrosia dell’autore a riconoscerne la paternità. Broggini è un intellettuale e la pubblicità non è considerata espressione artistica. Al cane a sei zampe, di fatto, manca un padrone che ne indichi l’indole e le caratteristiche.

L’assenza di una spiegazione sull’origine di quella strana creatura - un po’ cane un po’ drago - dà vita a numerose interpretazioni che finiscono per alimentarne il mito. In breve tempo, il cane a sei zampe“amico fedele dell’uomo a quattro ruote” - secondo un felice slogan ideato da Ettore Scola- diventa un elemento segnaletico, grazie alla moltiplicazione lungo le strade della Penisola di una nuova idea di stazione di servizio, assolutamente rivoluzionaria per l’epoca. Ispirata alle linee innovative dell’architettura americana, offre all’automobilista, oltre al rifornimento, servizi di ristoro di alta qualità.
**************************************************************************************************************************************



